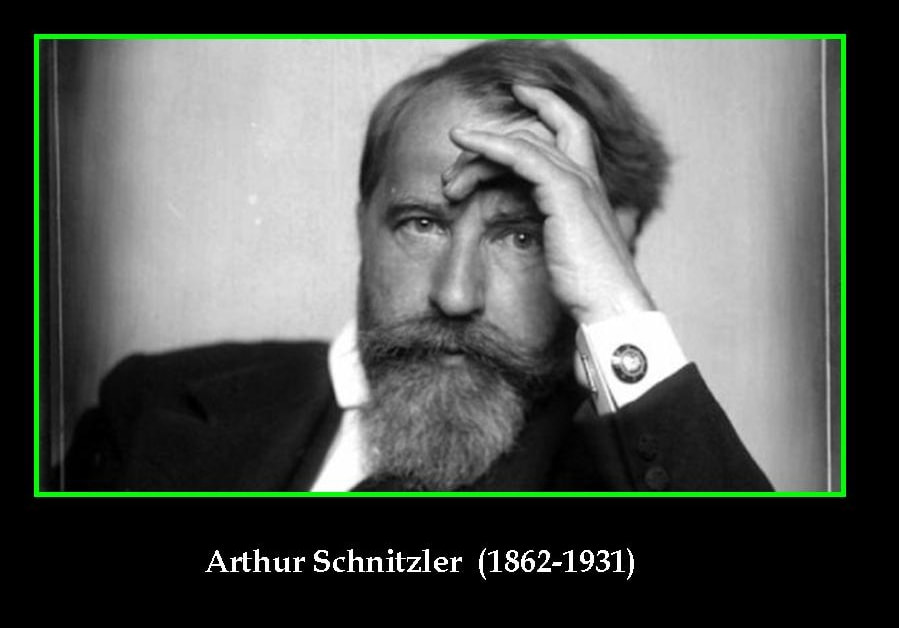Storia della Psicoanalisi
1. Sigmund Freud, Berggasse n.19, Wien:
dagli esordi della Psicoanalisi
al Congresso di Norimberga (1910)
“… Nel suo cinquantatreesimo anno di vita Casanova, che era ormai da tempo braccato per il mondo non tanto dalla brama di avventure della gioventù quanto dall'inquietudine dell'incalzante vecchiaia, sentì germogliare con tanto impeto nella sua anima la nostalgia di Venezia sua patria, che come un uccello il quale scenda lentamente dalle sue eteree altezze per morire, cominciò a tracciarle intorno volute sempre più strette.
Negli ultimi dieci anni d’esilio aveva già rivolto ripetute suppliche al Consiglio dei Dieci perché gli fosse permesso di rientrare in patria. […] Credeva di poter contare su un assenso, tanto più che le colpe dei suoi anni passati, tra le quali comunque per i consiglieri veneziani le più imperdonabili non erano la dissolutezza, la litigiosità e le imposture di natura per lo più scherzosa, ma il libero pensiero, stavano gradualmente finendo nel dimenticatoio e la storia della sua fuga mirabolante dai Piombi di Venezia, che egli aveva poi ripetutamente abbellito davanti a corti di regnanti, in castelli nobiliari, presso deschi borghesi e in case di malaffare, cominciava ad avere la prevalenza su ogni altra diceria legata al suo nome …”
da Arthur Schnitzler, Il ritorno di Casanova, 1918 (1)
Vienna conserva in modo quasi distratto e leggero la sua storia di grande capitale politica e sopratutto culturale. Nonostante faccia di tutto per cercare di dare di sé un aspetto moderno e proiettato verso il futuro, con moderni edifici che si slanciano verso l’alto in estese periferie, il suo passato grandioso appare impossibile da tenere in secondo piano. In fondo, fino a meno di un secolo fa, questa era la capitale del più antico degli imperi europei, uno stato formato da un insieme variegato di popoli, culture, lingue e religioni. Una capitale culturale e ideologica, prima ancora che politica. Era la Vienna di Franz Joseph, prima che la Grande Guerra venisse a sconvolgere per sempre quel precario, ma apparentemente immutabile equilibrio. La Prima Guerra Mondiale non fu sufficiente a spegnere la luce emanata dagli intellettuali viennesi. Saranno solo le tenebre del nazismo e l’annessione dell’Austria al Terzo Reich, nel 1938, a provocare la diaspora definitiva di quello era stato uno straordinario e forse irripetibile fiorire di intelligenze. Una sinfonia di vite e di straordinarie personalità, come le mille specie di rose che adornano oggi con i loro incredibili colori e forme i giardini dell’Hofburg, il vecchio palazzo imperiale, davanti al quale il monumento equestre del Principe Eugenio di Savoia sembra vegliare per l’eternità sul possibile ritorno di nuovi invasori dopo i Turchi che egli sconfisse più volte, impedendo forse in modo determinante l’instaurarsi di un’influenza islamica sull’Europa Occidentale. (2, 3)
Tra le figure di scienziati, filosofi, matematici che abbandonarono la loro patria in quel funesto 1938, c’era un vecchio medico, malato da tempo di un tumore al palato e alla faringe e già più volte operato e trattato con la radioterapia. Un paziente difficile, che nonostante la malattia continuava imperterrito a fumare i suoi amati sigari, uno dopo l’altro. Si chiamava Sigmund Freud ed era nato nel 1856 a Freiberg in Moravia. La città oggi si chiama Pribor ed è situata nel territorio della Repubblica Ceca. La casa natale di Freud è stata conservata con cura, insieme al suo piccolo giardino cintato. In questa provincia di confine del grande Impero Asburgico nacque Sigismund Schlomo Freud. Schlomo in ebraico vuol dire Salomone, ma Freud stesso nel 1877 fece scomparire questo nome dall’anagrafe, un nome che manifestava senza alcun fraintendimento la sua origine etnica. Il padre di Freud, Jacob, era infatti ebreo e faceva di professione il commerciante di lana. Proveniva dalla Galizia, una regione europea di cui si è perso il ricordo, ma che costituiva a quel tempo una realtà territoriale formata da parti dell’odierna Polonia, della Repubblica Ceca e dell’Ucraina, un territorio che l’imperatrice Maria Teresa d’Austria aveva ottenuto nel Settecento, all’epoca della spartizione della Polonia tra Prussia, Russia ed Impero Austro-Ungarico. Jacob Freud aveva sposato in terze nozze Amalie Nathanson (1835-1930), la madre di Sigmund, che resterà sempre molto legato alla figura materna.
La famiglia di Freud si trasferì a Vienna nel 1860 a causa di problemi economici. Il giovane Freud ricevette un’educazione ebraica di tipo tradizionale, seppure priva di eccessi ideologici. Lui stesso invece si appassionò allo studio della Bibbia, un interesse culturale che avrebbe lasciato tracce persistenti nei suoi futuri lavori. (4, 5) Frequentò con profitto il liceo a Vienna, dove si segnalò per le non comuni capacità intellettuali e si laureò in medicina nel 1881, senza abbandonare mai un forte senso critico nei confronti dei suoi insegnanti, di cui era solito evidenziare una certa inadeguatezza della visione scientifica, troppo ripiegata sulla modalità sperimentale, senza alcun tentativo di immaginare altri modelli di conoscenza. Dopo la laurea Freud si recò per un breve periodo in Inghilterra, dove venne a contatto con le teorie di Darwin e gli ambienti darwinisti. Ne apprezzò l’impostazione generale per una ricerca rigorosa, ma priva di fanatismi ideologici. Tornato in patria, il suo iniziale interesse per la zoologia e la biologia sperimentale lo spinse a lavorare per circa sei anni presso un celebre e stimato professore di Fisiologia dell’Università di Vienna, Ernst Wilhelm von Brücke, che Freud riterrà sempre come uno dei suoi maestri. Nel frattempo aveva cominciato a frequentare l’Ospedale Generale di Vienna, dove aveva incontrato la realtà di dolore e malattia costituita dai malati affetti da turbe e malattie neurologiche e psichiche. La Psichiatria gli appariva una specialità molto più promettente e redditizia economicamente della neurofisiologia sperimentale, che stava praticando presso il laboratorio di von Brücke. Occuparsi di malattie psichiatriche gli avrebbe permesso di rendersi economicamente indipendente in tempi meno indefiniti, una condizione a cui il giovane Freud aspirava con tenacia. (5, 6)
Freud aveva infatti conosciuto Martha Bernays, figlia di una ricca famiglia ebrea di Amburgo, che si era trasferita a Vienna. Freud riuscirà a sposarla nel 1886, dopo quattro anni di fidanzamento. Il matrimonio fu celebrato dopo un periodo di studio e di perfezionamento in Francia, alla scuola del celebre neurologo parigino Jean-Martin Charcot (1825-1893), presso l’Ospedale della Salpètriere di Parigi. Le nozze con Martha furono un traguardo importante nella vita di Freud, che rimase fortemente legato alla moglie per tutta la vita, parlando spesso di lei con un’apparente ed assoluta dedizione:
“…la mia Marta, la ragazza dolce di cui tutti parlano con ammirazione, che contro ogni mia resistenza è riuscita a catturare il mio cuore al nostro primo incontro, la ragazza che avevo timore a corteggiare e che venne verso di me con molta sicurezza di sé, che ha creduto in me e che mi ha dato speranza ed energia per impegnarmi nel lavoro quando ne avevo grande bisogno…”
da S. Freud, Lettera a Martha Bernays del 19 Giugno 1882 (7)
In realtà, al di là di un matrimonio solido e di un affetto ricambiato, la famiglia di Freud era piuttosto complicata. Freud ebbe sei figli e per ultima l’amatissima figlia Anna, che seguì la professione paterna fino a dedicarsi alla psicoanalisi infantile. Vivevano in famiglia la cognata di Freud, di nome Minna Bernays, sorella più giovane di Marta, che non si sposò mai e che pare abbia avuto una relazione con il cognato, non si sa se in accordo con la di lei sorella o in segreto. Facevano inoltre parte di questo grande nucleo familiare la madre di Freud, che visse fino a tarda età e ben tre donne di servizio. Tutte queste persone vivevano nei diciannove locali del grande appartamento in Bergasse, 19 a Vienna. Bergasse è una strada elegante e in salita, vicino al quartiere degli ospedali. Il palazzo dove visse Freud per circa quarantasette anni è una costruzione elegante, di colore chiaro, simile a tanti edifici abitati dalla borghesia benestante in molte grandi città europee del tempo. Freud occupava tre locali in una parte ben separata dal resto delle altre stanze. I tre locali del suo studio professionale si aprivano l’uno dopo l’altro fino al suo pensatoio riservato, con una finestra che dava su di un piccolo cortile alberato interno. Con il passare degli anni quelle stanze si riempirono di cimeli, di reperti archeologici e oggetti di antiquariato, che Freud aveva acquistato nei suoi viaggi e presso i mercanti di Vienna. Amava infatti l’Antichità Classica e la sua letteratura e arte, da cui attingeva ispirazione per molte idee e scritti. Era un uomo metodico, capace di lavorare instancabilmente per molte ore di seguito, anche se con il passare degli anni si trovò costretto, per le sue condizioni di salute, a limitare il tempo da dedicare ai pazienti e all’analisi dei loro disturbi psichici. (8)
Ancora giovane medico, Freud iniziò a studiare i fenomeni isterici al ritorno dal suo periodo di soggiorno a Parigi. Charcot utilizzava abitualmente l’ipnosi per la diagnosi e la terapie di tali forme nevrotiche e Freud nel 1889 aveva trascorso un breve periodo a Nancy, dove lavorava il neurologo francese Hippolyte Bernheim (1840-1919), che aveva sviluppato una notevole esperienza nell’ipnosi. Lo studio di queste tecniche furono uno dei motivi che fecero avvicinare Freud a un altro medico viennese, più vecchio di lui di circa quattordici anni. Il suo nome era Joseph Breuer (1842-1925) e si era interessato da anni all’isteria e ad una sua possibile terapia attraverso l’ipnosi. Breuer era già a quel tempo un medico famoso e ricercato. Il filosofo Friedrich Nietzsche (1844-1900) ad esempio, era stato curato da Breuer negli ultimi anni dalla follia che lo aveva afflitto. Freud aveva incontrato Breuer nel 1880 presso l’istituto di Fisiologia di von Brüke. Il rapporto con Breuer fu molto importante per il giovane Freud. Il collega più anziano esercitava su di lui un influsso positivo, stimolando emulazione e concorrenza scientifica nel suo più giovane collaboratore. La prima persona ad essere curata con la nuova tecnica basata sui colloqui del terapeuta con il paziente in stato di rilassamento, tecnica che proprio Freud aveva ideato, fu la celebre Anna O., una giovane donna il cui vero nome era Bertha Pappenheim e che soffriva di un’importante sintomatologia composta da paralisi intercorrenti e disturbi della visione e della parola. La paziente riferì di aver tratto giovamento dal raccontare ai medici il suo tormentato vissuto esistenziale, quasi che il narrare le proprie esperienze passate priva di freni inibitori, permettesse di alleviare lo stato conflittuale che le impediva di avere un rapporto equilibrato e sereno con la realtà. (9, 10)
Tuttavia Anna O. non era una persona ordinaria. Una volta controllati i sintomi isterici molto gravi da cui era affetta, Bertha Pappenheim divenne una giornalista e scrittrice di successo. Nata a Vienna nel 1859 da una famiglia ebrea tradizionalista, Bertha lottò tutta la vita contro i pregiudizi e le discriminazioni sociali del suo ruolo femminile. Molto impegnata socialmente, conosceva perfettamente tre lingue oltre al tedesco e svolse un’opera di promozione sociale della donna sia nel contesto della cultura ebraica da cui proveniva, che nel mondo della cultura tedesca del tempo. Con altre attiviste del Movimento Femminista, allora molto più attivo nel Regno Unito, fondò nel 1904 il Juedischer Frauenbund (La lega delle donne ebraiche), di cui rimase presidente per vent'anni. Era un organismo che lottava per la difesa legale dei diritti delle donne, richiedendo per loro pari opportunità di carriera e sociali. Ostile al Movimento Sionista, che identificava come un sostenitore del ruolo subalterno della donna nel mondo ebraico, Bertha decise di restare in Germania anche dopo l’avvento al potere di Hitler e le prime avvisaglie delle leggi razziali contro gli ebrei. Questa scelta le fu fatale, perché venne arrestata con un pretesto dalla Gestapo, la terribile e criminale polizia segreta nazista e morì in seguito alle torture ricevute nel maggio del 1936. (4, 8)
Il Metodo Catartico, come era stato battezzato da Freud, forse su suggerimento della stessa Pappenheim, sembrava funzionare. Nel 1895 uscì un lavoro importante per la storia della Psicanalisi: Gli Studi sull’Isteria, a firma di Joseph Breuer e Sigmund Freud. Questo libro segnò però la separazione tra le esperienze professionali dei due medici viennesi. Breuer era probabilmente rimasto troppo coinvolto emotivamente dal rapporto con la sua paziente e decise di abbandonare il sodalizio scientifico con Freud. Era caduto vittima di quel fenomeno che Freud avrebbe individuato e definito in seguito come Transfert, cioè il coinvolgimento sentimentale che poteva colpire il medico e il suo paziente quando queste due persone condividevano un piano profondo di conoscenza di idee e di aspettative esistenziali. (9, 11)
Rimasto solo a seguire la strada interpretativa dell’inconscio come fattore costitutivo della personalità, Sigmund Freud elaborò meglio il suo sistema di diagnosi e terapia dell’isteria. Si basò principalmente sullo studio dei sogni, un terreno questo che era sempre stato rifiutato da ogni forma di indagine razionale, prima che scientifica. Lavorando inizialmente sui suoi stessi sogni e ricordi, Freud elaborò una Teoria della personalità in cui il concetto di Io, da lui definito poi con il termine latino di Ego, assumeva un ruolo di fattore di conoscenza più marginale all’interno della psiche rispetto a quanto ritenuto in precedenza da filosofi e medici. Secondo Freud l’uomo non esisteva solo come soggetto cosciente. L’affermazione di Cartesio: Cogito ergo sum, doveva essere ridimensionata. L’Io cosciente era solo una parte della modalità conoscitiva della persona. Per giustificare la presenza di malattie psichiche, di cui non si poteva arrivare ad una spiegazione accettabile, bisognava immaginare la psiche umana come costituita da una parte cosciente e da una inconscia, un luogo psichico in cui venivano relegati traumi e conflitti scomodi e fonte di sofferenza per l’individuo. (11, 12)
L’inconscio diventava così un terreno di scoperta reale e conoscibile attraverso non la pratica indiscriminata e approssimativa dell’ipnosi, ma attraverso un dialogo guidato con il paziente e un’attenta osservazione dei suoi comportamenti per coglierne i lapsus e spiegare, dai sogni rivelatori che egli poteva raccontare, l’esistenza di conflitti interiori non risolti. Attraverso l’ideazione e l’applicazione di questo metodo di indagine Freud si convincerà di come molte patologie psichiche abbiano origine in conflitti interiori non risolti e di come tali conflitti vengano spesso “rimossi”, cioè tolti inconsapevolmente dallo stato di coscienza del soggetto e relegati in un livello inconscio della psiche umana. La diagnosi e la terapia di questi disturbi consisterà nel farli riemergere e nel rendere consapevole chi ne era afflitto delle problematiche che alteravano il suo stato di equilibrio. Raggiungere una diagnosi affidabile di una patologia nevrotica sarà dunque il modo di avere contemporaneamente a disposizione una terapia efficace per curare la nevrosi stessa. (12, 13)
La Teoria Psicoanalitica della Personalità e il raggiungimento di una visione complessiva dello svolgersi dell’esistenza attraverso lo strumento psichico dell’analisi, richiesero un lungo periodo di studi e di riflessioni. Diedero origine a tre scritti importanti di Freud che recavano il titolo di: L'interpretazione dei sogni, del 1899, La Psicopatologia della vita quotidiana, terminato nel 1901 e i Tre saggi sulla teoria sessuale, del 1905. Le idee di Freud suscitarono un dibattito e un movimento intellettuale in tutta Europa vasto e complesso. Secondo la prima elaborazione della Teoria freudiana della personalità, la mente umana poteva essere descritta come articolata in tre componenti:
- la parte cosciente, che si relazionava in modo consapevole con il mondo del reale (il Conscio);
- la parte non cosciente, in cui i ricordi e le esperienze negative o poco presentabili socialmente venivano conservate e quindi rimosse dall’ambito cosciente (l’Inconscio);
- una zona intermedia, chiamata Sub-conscio, che conteneva una serie di ricordi i quali non erano immediatamente accessibili alla memoria, ma che non comportavano una fatica particolare per essere riportati in superficie.
Freud propose una divisione del subconscio divenuta famosa, anche se in seguito sottoposta a critiche e ripensamenti dallo stesso Freud e da altri psicanalisti. Il subconscio venne da lui diviso in tre parti:
- l’Ego, Ich in tedesco e Io in italiano, costituiva la parte capace di interagire con la realtà fenomenologica del mondo esterno e di rappresentare una struttura di personalità sociale ben identificabile dagli altri uomini;
- l'Id, un termine latino traducibile con it in inglese ed es in tedesco, veniva rappresentato come il processo di identificazione–soddisfazione dei bisogni di tipo primitivo che stavano alla base delle esigenze innate dell’individuo. Costituiva la sua parte istintuale, dedita a seguire il principio di piacere. In realtà questo concetto non era stato formulato integralmente da Freud, ma aveva ricevuto una sua prima ipotesi fondante nell’opera di Georg Groddeck (1866-1934), medico e psicoanalista tedesco che si era interessato in particolare di medicina psicosomatica e che lo aveva elaborato per primo;
- il Superego o Überich in tedesco e Super-Io in italiano, che rappresentava la Coscienza, la parte della personalità individuale più attenta alle esigenze della morale e dell’etica. Il Super-Io si opponeva e contrastava efficacemente le istanze di realizzazione e di ottenimento di un piacere immediato avanzate continuamente dall’Es. (11, 13)L'Ego si interponeva tra l’Id e il Superego, sia per bilanciare le istanze di soddisfazione immediata dei bisogni primitivi, sia le spinte contrarie che derivavano dalle nostre opinioni morali ed etiche, le quali dovevano essere anch’esse modulate e ridotte nelle loro aspettative per poter permettere una vita “normale” all’individuo. Il cedere infatti completamente a una di queste due opposte polarità comportamentali avrebbe portato a una dissoluzione stessa della persona, nella sua ricerca spasmodica di adempiere al Principio di piacere seguendo l’Es, oppure, di converso, ad annullare i desideri più gratificanti e istintivi, che tuttavia se ben governati permettevano di apprezzare la vita. (13, 14)
Indagando quest’architettura ipotetica della mente umana, veniva definito come essa non fosse monolitica e omogenea, ma molto più composita e permeabile agli influssi ed esperienze interne ed esterne con cui era portata a confrontarsi fin dalla più tenera età. L’ipotesi freudiana costituiva una visione interpretativa della mente umana che ha rivestito e continua ad avere una grande influenza anche al di fuori degli ambiti della medicina e della psicologia, coinvolgendo le arti, i costumi e persino il linguaggio delle persone. Alcuni importanti scrittori del tempo di Freud, come Arthur Schnitzler (1862-1931) in Austria e Italo Svevo (pseudonimo di Ettore Schmitz, 1861-1928) in Italia, trassero dalla Psicoanalisi degli strumenti descrittivi e interpretativi delle angosce dell’Uomo moderno, mettendo in luce nei loro romanzi le contraddizioni esistenziali su cui era costruita la personalità umana. (15)
Schnitzler in particolare era medico e aveva conosciuto Freud al Policlinico di Vienna. Figlio e fratello di altri due medici, eserciterà senza troppa passione l’Otorinolaringoiatria, per poi dedicarsi completamente alla scrittura a partire dal 1893, anno della morte del padre. Uno dei racconti più belli di Schnitzler è il Ritorno di Casanova (Casanovas Heimfahrt), un romanzo breve e dalla trama verosimile, ma assolutamente fantastica, che racconta il soggiorno a Mantova di un Casanova cinquantenne che sta brigando da tempo per tornare in patria e rivedere la sua amata Venezia, la città da cui è fuggito in anni giovanili per darsi all’avventura ed al libertinaggio. Con un brano tratto da questo racconto, caratterizzato da una prosa elegante e da un’introspezione naturale, il celebre monologo interiore utilizzato dallo scrittore austriaco, abbiamo aperto questo capitolo. (1)
Vi sono altri libri di Schnitzler che possono essere citati per la profondità e la complementarietà delle riflessioni in essi contenute con le teorie psicoanalitiche. Molto conosciuto, grazie al film di Stanley Kubrick Eyes Wide Shut del 1999 a esso ispirato, è Doppio Sogno (Traumnovelle) del 1926, sul lato erotico più oscuro del rapporto di coppia. (16)
Il libro di Schnitzler che maggiormente risente di un’impostazione psicoanalitica è forse Fuga nelle tenebre (Flucht in die Finsternis) del 1931. In questo straordinario racconto assistiamo al progressivo cedere della personalità del soggetto narrante alle sue ossessioni. (17) Si tratta per Robert, il protagonista del romanzo, di un vero e proprio percorso verso la follia, in cui il suo io narrante ci conduce disvelandosi in tutte le sue fobie. La nevrosi di questo personaggio inizia sommessamente, qualche tempo dopo l’abbandono da parte della sua amante Alberta, che ha deciso di sposare un altro uomo. Inizialmente si tratta solo di ansie sfumate, di fobie, di timori, che scivoleranno progressivamente nell’angoscia di aver commesso chissà quali misfatti, delitti di cui però Robert conserva solo un tenue, ma straziante ricordo. Colpe di cui non si comprende mai fino in fondo se ne siano a conoscenza anche gli altri protagonisti del romanzo o si tratti invece solo fantasmi evocati dal suo rapporto disturbato con la realtà, distorsioni patologiche della sua sensibilità accesa e malata:
“… In quella trattoria, dove nessuno poteva supporre che si trovasse a quell’ora, nella luce crepuscolare di un primo pomeriggio di dicembre, gli sembrò di essersi staccato da tutti coloro ai quali, ancora la mattina, si era creduto umanamente legato; tutti: fidanzata, fratello e amici erano come ombre del passato. E allo stesso tempo ebbe l’impressione di dover anch’egli apparire in quell’ora come un’immagine sbiadita e fluttuante nel ricordo di quelle persone. Questa considerazione gli procurò dapprima solo una specie di brivido strano, quasi dolce, che si trasformò però a poco a poco in un leggero orrore; infine fu colto da un’angoscia che lo spinse a riprendere la strada della città attraverso viali umidi, spopolati e in penombra, come se ogni passo che lo portava più vicino alla vita reale avesse anche la forza di trasformare il suo ricordo sbiadito in un’immagine più precisa e vivace nel cuore di coloro che lo amavano…”
da Arthur Schnitzler, Fuga nelle tenebre (Flucht in die Finsternis), 1931,
trad. di Giuseppe Farese, Milano, 1985 (17)
A nulla serviranno i tentativi di salvarlo tentati da Otto, il fratello medico. Il suo sforzo paziente da terapeuta esperto di cercare di opporsi alla follia progressiva che ha invaso la mente del suo parente. Ormai incapace di resistere ad eventi tragici del tutto immaginari, ma per lui assolutamente reali, Robert ucciderà il fratello scambiandolo per uno dei suoi persecutori e troverà poi subito dopo la morte, cadendo in un dirupo in una fuga reale, ma ormai senza meta o possibile salvezza. Il libro si chiude con una riflessione del dottor Leinbach, un illustre medico viennese, un po’ filosofo e contemporaneamente spettatore molesto ed ingombrante di tutta la vicenda, la cui figura pare sia stata da Schnitzler tratteggiata sul modello dello stesso Freud:
“… Le annotazioni trovate nella sua borsa da viaggio furono consegnate al tribunale e rese pubbliche per sommi capi. Il caso era, in tutta la sua desolazione, assolutamente chiaro: mania di persecuzione, chi poteva dubitarne? Il dottor Leinbach, tuttavia, aveva una sua opinione in merito e non esitò ad affidarla alle pagine del suo accurato diario. « Il mio povero amico » scrisse « è stato tormentato dall’idea fissa, questo è il termine esatto, di dover morire per mano del fratello; e il susseguirsi degli avvenimenti gli ha dato alla fine ragione. Non è stato certo in grado di prevedere come si sarebbe giunti a poco a poco a quella conclusione. Ma non si può contestare che ne abbia avuto il presentimento. E cosa sono i presentimenti? Niente altro che ragionamenti nell’ambito dell’inconscio. La logica del metafisico, si potrebbe forse chiamarli. Noi parliamo invece di rappresentazioni ossessive! Se siamo autorizzati a farlo, se questo termine – come parecchi altri – non rappresenti in realtà una scappatoia – un rifugiarsi nel sistema per sfuggire alla irrequieta molteplicità dei casi singoli - questa è un’altra questione…”
da Arthur Schnitzler, Fuga nelle tenebre (Flucht in die Finsternis), 1931,
trad. di Giuseppe Farese, Milano, 1985 (17)
Bisogna sottolineare come alcune idee di fondo introdotte da Freud fossero talmente innovative ed imbarazzanti per la morale comune da risultare difficili da accettare per la Chiesa e le Istituzioni. La visione costitutiva della personalità umana, fondata secondo Freud sull’importanza attribuita alle pulsioni sessuali come elementi essenziali e regolatori della sua architettura, alimentò molte polemiche, sia tra la borghesia europea del tempo, che trovava scandaloso il parlare apertamente di questi argomenti, che tra gli addetti ai lavori, altri psichiatri spesso seguaci dello stesso Freud. Questi ultimi ritenevano eccessivo il ruolo che lo studioso viennese attribuiva alle pulsioni sessuali nel formarsi e nello strutturarsi della personalità dell’individuo. A dire il vero, certe idee di Freud interpretate senza troppe distinzioni davano facilmente origine ad uno sconcerto. Pensiamo solo alla sua visione del bambino come un soggetto polimorficamente perverso, espressione che stava a significare come un essere umano all’inizio della propria esistenza potesse avere già delle pulsioni di natura sessuale e potesse indirizzarle verso qualsiasi oggetto. La sessualità infantile risultava suddivisa, secondo Freud, in tre tappe successive: nella fase orale il bambino provava piacere dalla suzione del latte materno; in seguito, nella così detta fase anale, la defecazione e il soddisfacimento sensoriale che ne derivava divenivano l’occasione per provare un intenso piacere. Infine il bambino, verso il terzo anno di vita, avrebbe raggiunto la terza tappa della sua maturazione sessuale, quella che Freud definì come la fase genitale.
Questa condizione risultava a sua volta divisa in una fase fallica, in cui il maschio provava un’attrazione verso il suo stesso pene e la femmina invece un sentimento di invidia per tale organo di cui era sprovvista. Il termine di tale periodo avrebbe segnato l’ingresso nella fase genitale vera e propria, che si sarebbe poi estesa fino alla pubertà. Con una concezione ritenuta da alcuni un po’ maschilista, Freud affermò che la bambina sarebbe riuscita a superare l’invidia del pene solo attraverso la maternità, vista come unica e piena realizzazione del suo ruolo femminile. (6, 12)
Un altro aspetto ben conosciuto e significativo del pensiero freudiano, secondo il modello di sviluppo della personalità legato alle tematiche sessuali, è quello collegato ai Complessi di Edipo ed Elettra. Questi due comportamenti sono caratterizzati da un attaccamento spiccato per il genitore di sesso opposto a quello del fanciullo e da un’ostilità nei confronti del genitore dello stesso sesso. Freud elaborò queste teoria rifacendosi al mondo della Tragedia greca. Fece notare come il Complesso si verificasse dai tre a cinque anni di età e come fossero spesso gli stessi genitori ad accentuare questo stato di transizione, privilegiando il rapporto con i figli a scapito di quello con il proprio coniuge:
“…Il caso più semplice si struttura, per il bambino di sesso maschile, nel modo seguente: egli sviluppa assai precocemente un investimento oggettuale per la madre, investimento che prende origine dal seno materno e prefigura il modello di una scelta oggettuale del tipo "per appoggio"; del padre il maschietto si impossessa mediante identificazione. Le due relazioni per un certo periodo procedono parallelamente, fino a quando, per il rafforzarsi dei desideri sessuali riferiti alla madre e per la constatazione che il padre costituisce un impedimento alla loro realizzazione, si genera il complesso edipico. L'identificazione col padre assume ora una coloritura ostile, si orienta verso il desiderio di toglierlo di mezzo per sostituirsi a lui presso la madre. Da questo momento in poi il comportamento verso il padre è ambivalente; sembra quasi che l'ambivalenza, già contenuta nell'identificazione fin da principio, si faccia manifesta. L'impostazione ambivalente verso il padre e l'aspirazione oggettuale esclusivamente affettuosa riferita alla madre costituiscono per il maschietto il contenuto del complesso edipico nella sua forma semplice e positiva. Con lo sfacelo del complesso edipico deve essere abbandonato l'investimento oggettuale materno. In suo luogo possono prodursi due cose: o un'identificazione con la madre o un rafforzamento dell'identificazione con il padre. In genere consideriamo più normale quest'ultima soluzione; essa consente di serbare in una certa misura la relazione affettuosa con la madre. Grazie al tramonto del complesso edipico risulterebbe così consolidata la mascolinità nel carattere del maschietto. In modo del tutto analogo l'impostazione edipica della bimbetta può risolversi nel rafforzamento (o nella instaurazione) dell'identificazione con la madre, destinata a consolidare il carattere femminile della bambina…”
da S. Freud, L’Io e l’Es, 1923, in S. Freud, Opere, vol. 9, Torino, 1976-1980. (12)
In un saggio di Freud del 1912-1913, dal titolo di Totem e tabù, il Complesso edipico assumerà una valenza più generale e strutturale alla costituzione stessa della società. Nelle tribù primitive, l’odio del figlio nei confronti del padre sarà all’origine del periodico cambiamento nella gerarchia costitutiva del gruppo sociale di appartenenza. La necessità di alleviare il senso di colpa, generato nella prole dalla sostituzione nel ruolo paterno, darà origine in seguito a comportamenti rituali in grado di alleviare l’angoscia. Secondo Freud, questi comportamenti e un sistema complesso di prescrizioni e divieti costruito di conseguenza, erano alla base di molte nevrosi ossessive presenti nella società moderna. Nel 1909, dopo il consolidarsi del successo raggiunto dalle sue teorie tra i medici europei, Freud fu invitato a tenere un ciclo di conferenze negli Stati Uniti. Insieme a lui furono chiamati anche lo psichiatra svizzero Carl Gustav Jung (1875-1961) e altri due psicoanalisti, l’ungherese Sãndor Ferenczi (1873-1933) e il britannico Ernst Jones (1879-1958). Ne seguirono le Cinque conferenze sulla Psicoanalisi, tenutesi alla Clark University di Worchester, nel Massachussetts e un incontro di Freud con il filosofo pragmatista William James, medico e psicologo. Il viaggio in America costituì anche l’inizio dei dissapori tra Jung e Freud. Jung aveva infatti iniziato ad elaborare una sua teoria psicoanalitica della personalità in cui la libido, la pulsione base della personalità umana, dotata di caratteristiche prevalentemente di tipo sessuale secondo Freud, cessava di essere collegata soltanto all’attività sessuale, per assumere i caratteri di un’energia di fondo propria della psiche stessa. I continui richiami di Freud alla sessualità come motore principale del comportamento umano continuavano intanto a suscitare riprovazioni e prese di posizione scandalistiche da una parte e dall’altra dell’Oceano Atlantico. (4, 6)
In realtà, come hanno dimostrato alcuni studi, tra cui quello di Frank J. Sulloway dell’Università di Berkeley, le teorie di Freud sulla sessualità non provenivano dal nulla, ma erano un condensato armonico, non privo naturalmente di intuizioni originali, degli studi di altre personalità scientifiche dei suoi tempi, come quelli del medico e psichiatra tedesco Richard von Krafft-Ebing (1840–1902) e del suo collega inglese Havelock Ellis (1859-1939), i lavori dei quali avevano già suscitato scalpore nell’opinione pubblica dell’epoca. (10)
A Norimberga, il 30 e 31 marzo del 1910, si tenne un Congresso Internazionale di Psicoanalisi che nelle intenzioni dello stesso Freud doveva sancire la consacrazione di un Movimento Psicoanalitico omogeneo e scientificamente autorevole. Si trattò invece di un preludio alla frattura tra le diverse posizioni dei più celebri e autorevoli studiosi della materia. La proposta di eleggere Jung presidente a vita del Movimento, con potere di veto e di sconfessione degli articoli e teorie di altri studiosi che fossero stati giudicati eterodossi, venne respinta. La separazione ideologica e programmatica generatasi in questa sede tra freudiani, psicoanalisti svizzeri junghiani e viennesi, di maggiore o minore osservanza delle teorie di Freud, non rimase senza conseguenze.
2. Il dissenso di Adler e Jung
“… Cosa può crescere senza la pioggia?
Cosa può bruciare per interminabili anni?
La pietra può crescere senza pioggia,
ma solo l'amore può bruciare
per interminabili anni…”
dal film di Roberto Faenza, Prendimi l’anima, Italia, 2003
Il primo dei seguaci storici di Freud ad andarsene per proprio conto a elaborare una propria visione psicoanalitica della formazione della personalità fu Alfred Adler (1870-1937), psichiatra e psicoanalista austriaco. La separazione avvenne nel 1911. Adler uscì dal movimento rivendicando un ruolo di maggiore autonomia della persona nelle sue scelte e nella sua formazione psichica e comportamentale, proponendo una Teoria della personalità svincolata dal dominio della sessualità. Adler fondò una Società di Psicologia Individuale, che avrebbe avuto fortuna negli Stati Uniti, paese in cui egli si trasferì al sorgere della minaccia nazista. Secondo Adler, un Complesso di inferiorità, manifestatosi come disagio espresso dall’individuo, poteva essere superato grazie a varie forme di compensazione che modificassero lo stile di vita. (4, 14)
Questa percezione di inferiorità caratterizzava il bambino fin dalla nascita e dai primi anni del suo sviluppo ed era legata alla fragilità biologica del suo ruolo. Si poteva trasformare con il tempo in un sentimento d’inferiorità anche in età adulta, legato a carenze educative e ambientali che impedivano all’adolescente di liberarsene durante la crescita. La particolarità biologica di ogni individuo, come l’essere portatore di malformazioni o di una gracilità d’organo di tipo ereditario, potevano concorrere ad aggravare il quadro generale. Anche i conflitti presenti nel nucleo familiare, come la rivalità tra i fratelli o le preferenze genitoriali erano importanti in questo processo. La soluzione a questa condizione di disagio consisteva nell’autoinganno dell’individuo, che si creava uno stile di vita e degli obiettivi sociali e personali gratificanti da raggiungere, per ottenere una migliore considerazione nei suoi confronti da parte delle persone con cui interagiva. Alcuni di questi comportamenti potevano essere di natura negativa, come la frigidità della donna, comportamento questo basato su di un’auto-repressione femminile da parte di una donna che non accettasse un presunto ruolo dominante del maschio. Il mancato superamento del Complesso di inferiorità avrebbe portato a una serie di comportamenti nevrotici e patologici, impedendo all’individuo di integrarsi in modo armonioso con la società di cui era chiamato a far parte. La volontà di potenza individuale e il desiderio di autoaffermazione erano dunque chiamati ad armonizzarsi con le regole sociali e con l’essere chiamati a ricoprire un ruolo significativo e positivo. (4, 11)
Un individuo che provenisse da una famiglia con ruoli genitoriali non armonici, come un padre troppo autoritario e una madre possessiva e contemporaneamente affettivamente distante, poteva aver subito gravi danni al suo equilibrio psichico. Avrebbe avuto delle serie difficoltà a una sua integrazione socialmente utile.
Scrisse Adler in proposito:
“…Non possiamo giudicare nessun bambino, nessun adulto, se non mettiamo a confronto il senso comunitario posseduto con la quantità dello sforzo fatto per valere e per prevalere sugli altri. Il fine viene fissato in modo tale che la sua realizzazione renda possibile il senso della propria superiorità e consenta uno sviluppo tale della propria personalità da rendere la vita degna di essere vissuta. È questo fine che conferisce perfino alle sensazioni il loro valore, che dirige e influisce sulle percezioni, dà forma alle rappresentazioni, guida la forza creatrice con cui le suscitiamo in noi, o con cui perfezioniamo i ricordi o li accantoniamo. […] se riflettiamo che inoltre cerchiamo in ogni evento di realizzare quell’aspetto che ci sembra idoneo ad attuare il nostro scopo, allora è comprensibile che anche qui tutto rimanga relativo e la sicurezza e la stabilità dei valori sia solo apparente. Solo in base a una finzione, per una specie di effettiva forza creatrice, ci ancoriamo a un punto fisso, che nella realtà dei fatti non esiste. Tale ipotesi, a rigore dovuta a una manchevolezza della vita psichica umana, assomiglia ai molti tentativi della scienza e della vita, come quello della partizione del globo in meridiani, in realtà inesistenti e molto valido solo come ipotesi. In tutti i casi di finzione psichica la situazione è la seguente: supponiamo un punto fisso per ottenere un orientamento nel caos della vita, per poterci contare, pur dovendoci persuadere a un esame più preciso che non sussista. Tutto ciò che inizia da una sensazione viene tramutato in noi in un dominio su cui possiamo contare, nel quale possiamo agire. Tale è il vantaggio che l’assunzione di un fine costante consente alla vita psichica umana…”
da A. Adler, Conoscenza dell’Uomo, in Freud-Adler-Jung, Psicoanalisi e filosofia,
a cura di A. Crescini, Brescia, 1983 (18)
Le teorie di Adler, attente al rapporto tra individuo e società e influenzate dal dibattito presente in quegli anni nella cultura marxista, riscossero un notevole successo negli Stati Uniti e svolsero un ruolo e un influsso importante sull’opera di studiosi originali come Eric Fromm (1900-1980), che fu amato come divulgatore di psicologia esistenziale dal grande pubblico di molti paesi. (19, 20)
L’altro grande ribelle con cui Freud si dovette confrontare fu lo psichiatra svizzero Carl Gustav Jung (1875-1961). Nei primi anni di lavoro seguace devoto del maestro viennese, tanto da essere considerato il suo erede designato, Jung andò elaborando nel tempo una sua teoria autonoma della personalità. Nato nel cantone di Turgovia, a maggioranza protestante, Carl era figlio di Paul Jung, un teologo e pastore della chiesa locale che si trasferì a Basilea nel 1879. In questa città, oltre ad esercitare la sua carica religiosa, il padre di Jung si adoperava nella cura delle anime del manicomio di Basilea. Bambino riflessivo e solitario, Jung si iscrisse alla facoltà di Medicina di Basilea, dove si laureò nel 1900 con una tesi sulla Psicopatologia dei fenomeni occulti, un argomento questo che lo avrebbe affascinato anche negli anni a venire. Poco dopo la laurea, Jung cominciò a lavorare all’Istituto Psichiatrico dell’Università di Zurigo e nel 1903 si sposò con Emma Rauschenbach, dando inizio a una lunga unione matrimoniale durata fino alla morte di lei nel 1955. La vita che Jung trascorse a Zurigo, giovane medico già molto stimato, cultore della Psicoanalisi e delle innovative teorie freudiane, fu inizialmente turbata dal caso clinico ed umano di Sabine Spielrein (1885-1942). Sabine era una giovane affetta da isteria, figlia di un ricco mercante russo di religione ebraica. Disperando di poter curare la figlia con i metodi della psichiatria tradizionale, allora di tipo brutalmente coercitivo e contentivo, i genitori si rivolsero a Jung nel 1904. La terapia psicoanalitica che Jung utilizzò nell’Ospedale di Zurigo, il Burghölzli, insieme all’abbandono dei metodi di contenzione, fecero il resto. Sabine guarì, anche se l’utilizzo di questo termine può sembrare un po’ limitativo. La giovane donna si innamorò, ricambiata, dello stesso Jung. La relazione, coinvolgente ed appassionata, durò dal 1908 fino al 1911. (21, 22)
Inizialmente Jung visse questo sentimento con trasporto, ma allo stesso tempo sconcertato dal fatto di non riuscire a controllare i propri sentimenti. Preoccupato, ne scrisse a Freud, dando origine ad uno dei carteggi più interessanti e suggestivi della storia della Psicoanalisi, lettere illuminanti sul rapporto tra Freud ed Jung, come su quello medico-paziente e su alcuni dei suoi lati più oscuri:
Burghölzli-Zurigo, 23 ottobre 1906
Stimatissimo professore [Freud], mi permetto di spedirLe, con la stessa posta, un nuovo plico a parte che contiene altre ricerche in tema di psicoanalisi... Devo abreagire [rielaborare] su di Lei un’esperienza recente, a rischio di annoiarla. Sto applicando attualmente il Suo metodo alla cura di un’isteria. E’ un caso difficile: una studentessa russa ventenne, ammalata da sei anni. Primo trauma: verso il terzo-quarto anno di vita. La bimba vede il padre che percuote sul sedere nudo il fratello maggiore. Forte impressione: in seguito è costretta a pensare di aver defecato sulla mano del padre. Dal quarto al settimo anno continui tentativi di defecare sui propri piedi, compiuti nel modo seguente: si siede per terra tenendo un piede ripiegato sotto il corpo, preme il calcagno contro l’ano e cerca di defecare e, al tempo stesso, di impedire la defecazione. In questo modo frena più volte l’evacuazione anche per due intere settimane! Non so come sia arrivata a questa storia stranissima; si trattava, così pare, di un fatto di carattere assolutamente pulsionale, accompagnato da una deliziosa sensazione di orrore. In seguito questo fenomeno è stato sostituito da una masturbazione intensa. Le sarei estremamente grato se volesse comunicarmi in poche parole la sua opinione su questa storia.
Con stima deferente, Suo devotissimo C. G. Jung
da Lettere tra Freud ed Jung, Torino, 1974 (23)
Applicando il colloquio psicoanalitico e altre nuove tecniche terapeutiche, come le libere associazioni e facendo probabilmente leva, in modo più o meno consapevole, su di un ascendente seduttivo esercitato nei confronti della stessa Sabine, Jung riuscì ad aiutare la ragazza a mettere sotto controllo le proprie pulsioni nevrotiche ed autodistruttive. Stimolata in proposito dallo stesso Jung, che ammirava l’intelligenza e la capacità di autocritica e autoanalisi della sua paziente, Sabine iniziò a studiare medicina. Nel giugno del 1905 si iscrisse alla Facoltà di Medicina dell’Università di Zurigo. Nel 1911 Sabine si laureò, con una tesi dal titolo di Il contenuto psicologico di un caso di Schizofrenia, elaborata sotto la guida di Jung, che venne pubblicata sullo Jahrbuch [Annuario], la rivista ufficiale del Movimento psicoanalitico. Negli anni immediatamente precedenti, a partire dal 1908, la relazione tra Jung e la Spielrein era divenuta intanto una vera e propria passione, non si sa bene quanto tollerata dalla moglie di Jung, che forse ne era a conoscenza da tempo. Di questa sua evoluzione sentimentale Jung teneva costantemente al corrente Freud, che lo confortava con parole un po’ distaccate, quasi osservasse il divenire della vicenda con occhi esclusivamente professionali e lasciasse invece su di un altro piano la partecipazione affettiva, che pure tante volte aveva manifestato al suo allievo. Scrisse Jung a Freud:
Burghölzli-Zurigo, 7 marzo 1909
“... attualmente sono terribilmente perseguitato da un complesso: una paziente che anni fa ho strappato con estrema dedizione a una gravissima nevrosi ha deluso la mia fiducia e la mia amicizia nel modo più offensivo che si possa immaginare. Mi ha provocato uno scandalo unicamente perché ho rinunciato al piacere di darle un figlio. Mi sono sempre comportato come un gentiluomo con lei, ma non mi sento limpido di fronte alla mia coscienza un po' troppo sensibile, e questo mi fa soffrire più di ogni altra cosa, perché le mie intenzioni sono sempre state oneste... Queste esperienze dolorose eppure quanto mai salutari hanno scatenato l’inferno in me, ma proprio perciò mi hanno assicurato, spero, qualità morali il cui possesso sarà di estrema utilità per la vita futura...
dal Suo devotissimo Jung”
da Lettere tra Freud ed Jung, Torino, 1974 (23)
Alla lettera preoccupata di Jung, seguì rapidamente la risposta di Freud, che poneva la vicenda in un contesto di normalità. Si era trattato di un “incidente professionale” a cui si doveva sottostare come ad uno dei rischi più frequenti della pratica psicoanalitica:
Vienna, IX Bergasse, 19 - 9 marzo 1909
“Caro amico... Anche a me è arrivata notizia di quella paziente che Le ha insegnato la gratitudine nevrotica dell’amante disprezzata. Muthmann [un altro psicoanalista], durante una visita, parlò di una certa dama che si era presentata a lui come la Sua amante; egli commentava che, se Lei era riuscito davvero a conservarsi tanta libertà, la faccenda lo impressionava. Ma eravamo ambedue concordi nel supporre che le cose stessero altrimenti e non si potessero spiegare senza tener conto delle nevrosi di chi ce le aveva raccontate. Essere calunniato e rimanere scottati dall’amore con cui operiamo, sono questi i pericoli del nostro lavoro, a causa dei quali però non abbandoneremo certo la professione...”
Cordialmente, Suo Freud”
da Lettere tra Freud ed Jung, Torino, 1974 (23)
In quegli anni, tra il 1908 ed il 1910, la passione di Sabine per Carl esplose in tutta la sua intensità. Furono una passione e un amore ricambiati, anche se Jung non riuscì a viverli fino in fondo. Sensi di colpa per il torto cui sottoponeva la moglie, diminuzione della sua autostima personale di psichiatra e psicoanalista per non essere riuscito a proteggersi dal tranfert affettivo che lo aveva investito come un’onda calda di passione nella gelida e protestante Zurigo, concorsero ad impedire che l’amore tra Carl e Sabine trovasse il suo epilogo in una convivenza alla luce del sole e magari nel concepimento di un figlio, come pare la donna gli avesse chiesto. Jung si allontanò con tutte le sue forze da Sabine, strappandosi dal cuore le radici di quell’amore che riteneva di non potere o dover vivere. Ma al posto delle radici di quella pianta cui stava rinunciando rimasero ferite e rimpianti che lo avrebbero accompagnato per il resto dei sui giorni. Scrisse ancora Jung al suo maestro:
4 giugno 1909, Im Feld, Küsnach-Zurigo
“Caro Professore, la Spielrein è la stessa persona della quale Le ho scritto. Il suo caso è stato pubblicato in forma abbreviata nella mia relazione di Amsterdam di beata memoria. E’ stato il mio caso psicoanalitico “da manuale”, per così dire, ragion per cui ho conservato per lei una particolare gratitudine e affezione. Poiché sapevo per esperienza che sarebbe ricaduta subito se le avessi rifiutato la mia assistenza, il rapporto s’è trascinato per anni e io ho finito col ritenermi quasi moralmente impegnato a concederle anche in seguito la mia amicizia, fino al momento in cui vidi che questo metteva in moto una rotella imprevista e perciò alla fine ho troncato. Essa aveva naturalmente programmato di sedurmi, cosa che io consideravo inopportuna. Ora sta maturando la sua vendetta. Recentemente ha sparso la voce che entro poco tempo divorzierò da mia moglie e sposerò una certa studentessa, cosa che ha suscitato una certa agitazione presso alcuni miei colleghi. Non so cosa abbia in mente ora: niente di buono a quanto presumo. Penso che voglia abusare di Lei coinvolgendoLa in un tentativo di mediazione....
Suo Jung”
da Lettere tra Freud ed Jung, Torino, 1974 (23)
In questo modo, le cose tornavano nel loro alveo di apparente normalità. Il Super-Io di Jung aveva vinto ed aveva riconquistato il suo posto preminente nell’organizzazione delle volontà dello studioso. La sua personalità rispettabile si ricomponeva davanti agli occhi della società Zurighese del tempo. Jung poteva tornare ai suoi studi ed alle sue comunicazioni ai congressi, senza l’impaccio imbarazzante di una donna appassionata che destabilizzava il suo cuore e la sua vita con la forza dell’amore. Leggiamo ora quest’ultima lettera di Freud a Jung, che sembra distillare saggezza e compostezza, oltre che lucida consapevolezza dei pericoli cui si può incorrere a voler guardare troppo in profondità dentro sé stessi e gli altri, abbandonando per imprudenza e insieme inarrestabile affettività, lo scudo imposto dalla professione e dal ruolo:
7 giugno 1909, Vienna, IX Bergasse, 19
Caro amico, poiché so che Lei è personalmente interessato alla questione Spielrein, Le scrivo ancora in proposito... Dopo il telegramma ho dunque scritto una lettera alla Spielrein, in cui facevo l’ingenuo, come se avessi da giudicare l’offerta di una seguace troppo entusiasta. Ma dicevo di non potere assumermi la responsabilità di un suo viaggio, dato che si trattava di una cosa così interessante per me; d’altra parte, aggiungevo di non sapere che cosa la spingesse a fare questo sacrificio; e perciò la pregavo di comunicarmi prima di tutto per lettera di che genere fosse la questione. Non è ancora giunta risposta. Esperienze del genere, sebbene dolorose, sono necessarie e difficilmente ci si può sottrarre da esse. Solo dopo averle vissute si conoscono la vita e ciò con cui si ha a che fare. Quanto a me, non ci sono cascato del tutto, ma alcune volte mi ci sono trovato assai vicino e ho avuto «a narrow escape» [sono riuscito a cavarmela per un pelo]. Io credo che soltanto le dure necessità in mezzo alle quali il mio lavoro si è svolto e i dieci anni di ritardo rispetto a Lei, prima che giungessi alla psicoanalisi, mi hanno preservato da esperienze analoghe. Ma non fa nulla. Ci si fa in tal modo la necessaria pelle dura, si domina la “controtraslazione” in cui ci si viene a trovare ogni volta e si impara a spostare i propri affetti ed a piazzarli in modo opportuno…”
Suo Freud
da Lettere tra Freud ed Jung, Torino, 1974 (23)
Sabine Spielrein era comunque una persona straordinaria. Seppe reagire con dignità all’abbandono da parte di Jung e continuò i suoi studi. Si interessò con particolare originalità alla comprensione di quel fenomeno psicoanalitico che andava prendendo il nome di Istinto di morte e il 25 novembre del 1911, alla presenza di Freud e altri professionisti della Psicoanalisi, terrà una relazione proprio su questo argomento. La reazione dei partecipanti all’incontro scientifico non fu troppo positiva. Tuttavia Freud, molti anni dopo quella conferenza, confessò di essersi reso conto dell’acuta intuizione della Spielrein su di un argomento, la pulsione distruttiva, che lui stesso aveva avuto inizialmente qualche reticenza ad accettare. Ammessa a far parte della Società di Psicoanalisi, Sabine continuo la sua vita di medico e di ricercatrice dell’animo e della personalità umana. Si sposò con Pavel Scheftel, un medico russo anch'egli di origine ebrea, da cui ebbe due figlie: Renate ed Eva. Nel 1923 ritornò con la famiglia in Russia e fondò a Mosca, insieme alla psicoanalista russa Vera Federovna Schmidt (1889-1937), un asilo infantile chiamato l'Asilo Bianco. In questo luogo di accoglienza per bambini e fanciulli, le cui pareti e arredi erano dipinti di bianco per stimolare un senso di serenità e di tenerezza nelle anime dei bimbi, Sabine applicò innovative modalità di educazione, con una particolare attenzione ai conflitti interiori e alla risoluzione dei traumi familiari che quelle giovani vite potevano aver ricevuto. Nonostante le ristrettezze materiali e morali del periodo stalinista, si trattava di principi molto avanzati per l'epoca. Si cercava di far crescere i bambini come persone libere, lontani da condizionamenti violenti. L’Asilo Bianco venne però chiuso dalle autorità sovietiche con l'accusa di praticare principi educativi contrari alla dottrina del partito, anche se si dice che lo stesso Stalin avesse a suo tempo iscritto all’Asilo, sotto falso nome, il proprio figlio. Il marito di Sabine fu ucciso nel 1936 durante le purghe staliniane ed un destino tragico era stato riservato anche a lei. Nel 1942, durante l’invasione nazista della Russia, Sabine fu portata con le figlie nella sinagoga di Rostov in quanto ebrea. Là venne uccisa, insieme ai suoi cari. Si ignora dove siano finite le sue spoglie mortali, probabilmente in una fossa comune senza nome. La vicenda di Sabine era stata ormai accantonata da un punto di vista esistenziale, quando Jung iniziò a staccarsi dalla concezione freudiana della Teoria della personalità. Nel 1912 pubblicò un testo che si metteva in contrasto con la visione speculativa del suo maestro viennese. Si trattava di Trasformazioni e simboli della libido. (21, 24)
Il libro conteneva molti elementi di disaccordo sulla natura dei costituenti della psiche. Il nucleo centrale delle idee di Jung era basato sul diverso peso da lui attribuito alla sessualità come componente essenziale della Libido. Secondo Jung, la Libido non doveva essere vista come una costituente energetica della psiche umana, che si alimentava soltanto attraverso le pulsioni sessuali, come era stato sostenuto da Freud. La Libido era invece una specie di contenitore di energia psichica, le cui componenti non erano influenzate solo dal sesso. Si trattava di un’energia di fondo e presente da sempre nella psiche, che poteva essere incanalata in varie direzioni. Il sesso continuava ad esercitare un’azione profonda su di essa, ma non costituiva che una delle forze in gioco. In questa visione, la Sessualità manteneva un compito importante, ma concorreva tuttavia con altre forze a delimitare e a incanalare i pensieri e le azioni dell’individuo. (11, 25)
La Libido era dotata di una sua intrinseca capacità evolutiva, poteva avere come oggetto della sua attenzione delle idee o delle entità non dotate di una natura materiale e quindi poteva ascendere attraverso di esse a una forma di spiritualità, a una vera e propria trascendenza. Nel caso tale evoluzione venisse arrestata o impedita, potevano sorgere le nevrosi. Queste patologie dovevano intendersi non solo come processi che traevano la loro origine dall’infanzia, in seguito a episodi che avevano generato conflitti non risolti o rimossi a sfondo e natura sessuale. Le nevrosi erano attribuibili anche a conflitti spesso contemporanei allo svolgersi della vita dell’individuo, legati alla frustrazione provocata nella persona dalla sua incapacità di adattarsi all’ambiente che lo circondava e all’impossibilità di agire per cambiarlo. (11, 25)
L’esito finale poteva essere l’instaurarsi di un comportamento di inerzia, il riconoscimento della propria impotenza, che avrebbe portato alla regressione della Libido verso comportamenti primitivi e infantili. Questa forza diveniva così la pulsione dinamica alla base della vita, il fattore che ne garantiva la conservazione e l’evoluzione senza fine, protesa verso un futuro con caratteristiche di intrinseca positività e ottimismo. La teoria psicoanalitica di Freud, basata sulla Libido intesa come un coacervo oscuro di pulsioni sessuali più o meno risolte e definite, sembrò dunque a Jung troppo pessimistica per essere messa a fondamento della natura e delle caratteristiche della personalità umana. (24, 25)
Di un essere umano, potremmo aggiungere, che aveva avuto l’opportunità di crescere e maturare in una società civile e magari nella migliore di tutte queste, come nell’ordinata e apparentemente tranquilla Zurigo, dove lo stesso Jung aveva avuto la ventura di vivere. Una città simbolo di una nazione, la Svizzera, che sarà risparmiata almeno fisicamente dalle ondate di morte e di disperazione di due Guerre Mondiali che stavano per sommergere l’Europa. Sulla strada di una giustificazione positiva della natura psichica dell’uomo, Jung elaborò un’interpretazione simbolica della realtà, la sola secondo lui capace di spiegare compiutamente il dipanarsi multiforme dell’energia psichica. Secondo le sue conclusioni speculative la rappresentazione simbolica era presente già nell’uomo primitivo. Grazie all’identificazione del comune sentire umano in simboli universali, come ad esempio la vecchiaia, la ruota, le stelle, la figura della Grande Madre, era stato creato con il trascorrere dei secoli un Inconscio collettivo, un luogo metaforico in cui la psiche del singolo poteva attingere per trovare sicuri punti di riferimento e incanalare le proprie energie per partecipare alla costruzione della civiltà e del progresso. (25, 26)
I simboli della natura universali e riconosciuti da tutte le culture umane vennero definiti come degli archetipi, modelli di comportamento comuni a tutte le civiltà, che si trasmettevano in modo ereditario come costituenti fondamentali della Libido stessa. Formavano una specie di memoria storica dell’esperienza umana, una memoria collettiva con cui l’individuo si doveva confrontare nella sua formazione ed evoluzione della personalità fin dagli anni dell’infanzia. Le rappresentazioni della mente umana, che mediavano l’interazione fra la coscienza e l’inconscio e fra l’inconscio individuale e l’inconscio collettivo, vennero articolate da Jung secondo un equilibrio dinamico tra due opposti. Erano coppie di concetti in contrasto fra di loro, espressione di realtà completamente differenti. Una di queste coppie di opposti si verificava nell’Io, inteso come un insieme di rappresentazioni psichiche coscienti e di natura stabile, in cui era riposta l’identità dell’individuo. L’Io era per Jung una struttura psichica basata su principi e valori accolti con adesione totale dall’individuo e riconosciuti come positivi. Un altro aspetto dell’Io era formato da ciò che Jung definì come l’Ombra, intesa questa come un insieme di possibilità esistenziali che venivano respinte dalla coscienza del soggetto e ritenute delle istanze non pertinenti oppure non accettabili, in quanto considerate di valenza negativa. (25, 26)
Per quanto riguardava l’Incoscio Collettivo, una forma di variante dell’Archetipo-Ombra poteva essere considerata la rappresentazione culturale che veniva fatta del Diavolo, un archetipo visto come un insieme di aspettative malvage e da rigettare. Suggestiva fu l’interpretazione fornita da Jung della Religione. Nella visione psicoanalitica junghiana la Religione diventava una forma estremamente raffinata di rappresentazione simbolica, capace di deviare le istanze della Libido fuori da quell’ambito strettamente famigliare in cui Freud le aveva confinate nella sua prima interpretazione psicoanalitica della personalità. In questo modo la Libido e la sua energia psichica si rendevano disponibili ad un’interpretazione e a un utilizzo positivo di tipo socialmente utile. Secondo Jung, la Religione rivestiva una funzione decisiva nello sviluppo della civiltà umana. In questo caso appare facile ravvisare nello psichiatra svizzero le influenze familiari e l’autorevolezza della figura paterna che, non dimentichiamolo, era stato un pastore protestante. Nell’ultima parte della sua lunga vita Jung sarà molto critico nei confronti della società moderna e dei fenomeni di massificazione da essa indotti, comportamenti che si presentavano insieme alla perdita di un senso religioso e spirituale della vita. Manifesterà invece un vivo interesse per le culture primitive, le religioni orientali e tutto il loro grande bagaglio simbolico, viste come un momento di critica allo strapotere della Scienza moderna, che credeva di poter cambiare la vita di ogni uomo in senso positivo. Quello studiato da Jung era un universo ideologico e culturale diverso dal mondo moderno e ai suoi occhi capace testimoniare con coerenza la presenza di archetipi spirituali e del senso del trascendente nella vita umana, comportamenti che erano diventati difficili da osservare nel mondo contemporaneo. (21, 24)
Con l’avanzare dell’età Jung prese l’abitudine di trascorrere sempre più tempo presso la così detta Torre di Bollingen, un edificio singolare, privo di corrente elettrica e di acqua corrente, che aveva fatto costruire sulle rive del lago di Zurigo. Viveva in questa strana casa buona parte dell’anno, separato dal mondo e immerso in un totale silenzio, Era un tempo dedicato alla riflessione e alla elaborazione di idee molto critiche sull’evoluzione della società moderna, che sembrava restringere sempre più gli spazi alla funzione creatrice dell’Uomo e alla ricerca del trascendente. Una società che pareva unicamente capace di dare spazio a nevrosi e credenze negative, sempre diverse e nuove. A Bollingen, sulle rive di un lago dalle acque spesso scure ed insondabili, Carl Gustav Jung morì nel giugno del 1961.
3. La seconda parte della vita
e della concezione freudiana del mondo
Il 28 giugno del 1914 l’Arciduca d’Austria ed erede al trono Francesco Ferdinando e sua moglie Sofia furono uccisi in una strada di Sarajevo dai colpi di una pistola di fabbricazione belga, maneggiata con imperizia, ma con risultati devastanti, da Gavrilo Princip, un giovane congiurato serbo della setta "Giovane Bosnia" (Mlada Bosna), la quale propugnava l'annessione della Bosnia alla Serbia. Princip dichiarò di avere parzialmente fallito nel suo attentato e di non aver voluto uccidere la moglie dell’arciduca, ma il governatore di Sarajevo. Tentò quasi immediatamente di uccidersi al momento della cattura con una pastiglia di cianuro e con un colpo della sua stessa pistola, ma il veleno non funzionò e riuscì solo maldestramente a ferirsi di striscio. Morirà di tubercolosi quattro anni dopo in un carcere austriaco, mentre scontava una condanna a vent’anni di carcere cui era stato condannato con una certa clemenza, grazie alla sua giovane età: Princip aveva infatti solo diciannove anni.
Il vecchio Impero Asburgico non aveva infierito troppo sull’autore materiale dell’attentato, ma a livello internazionale le cose andarono in modo diverso e ben più tragico. Nel giro di un mese tutte le più importanti nazioni europee entrarono in guerra, trascinate da una cascata inevitabile di alleanze e arroganza reciproca, mentre l’Europa iniziò ad autodistruggersi. Le ragioni di fondo del disastro furono costituite dalla sottovalutazione del potere distruttivo delle armi moderne, unita alla ormai effettiva e misconosciuta globalizzazione del Mondo, che avrebbero esteso le conseguenze del conflitto in ogni parte del pianeta. La reazione iniziale di Freud, come quella di tanti ebrei di lingua tedesca, fu di positiva e leale solidarietà con i destini della loro patria. Ernst Jones (1879-1958), discepolo e biografo di Freud, racconta come il suo maestro abbia accolto la guerra con la convinzione che questa avrebbe potuto rappresentare un fattore di stabilità e promozione sociale per il suo gruppo etnico. (6)
Si trattava di una speranza destinata ad essere amaramente e rapidamente disillusa. Già nel novembre del 1914, in una lettera indirizzata all’amica Lou Andreas Salomè (1861-1937), Freud manifestava tutto il suo rammarico e le preoccupazioni per una guerra che stava ormai devastando l’Europa:
“… l’Umanità, non ne dubito, si rimetterà anche da questa guerra; tuttavia sono certo che né io, né i miei coetanei, rivedremo mai più un mondo felice. Tutto è troppo orribile, ma quel che è triste è che le cose vanno esattamente come avremmo dovuto immaginarcele in base a quanto la psicoanalisi ci ha insegnato sulla natura e sul comportamento degli uomini […] Ecco la mia segreta convinzione: se nella nostra civiltà attuale, che è di tutte la più alta, non si ravvisa che un’enorme ipocrisia, evidentemente siamo organicamente inidonei a rappresentare questa civiltà. Non ci resta che abdicare e il grande Sconosciuto, persona o cosa, che si cela dietro il fato, ripeterà un giorno il suo esperimento con un’altra razza …”
da Lettere tra Freud e Lou Andreas Salomè 1912-1936 (27)
I figli maschi di Freud, Oliver, Ernst e Martin, vennero chiamati alle armi e combatterono per tutta la durata della guerra. Martin, inizialmente dato per disperso, risultò invece essere stato fatto prigioniero in Italia. Solo verso il 1918, con il volgere al termine del conflitto, l’attività creativa di Freud, che si era come affievolita per quattro anni, riprese forza. La pace ed il crollo del vecchio mondo asburgico vennero da lui accolti con soddisfazione. Confessò alla figlia Anna che non avrebbe certo versato lacrime per il tramonto dell’Impero, il quale venne smembrato in diverse e più modeste realtà nazionali. Nell'arco di due anni Freud pubblicò varie opere, alcune delle quali divennero celebri e in cui i principi stessi della psicoanalisi, nati per affrontare patologie del comportamento individuali, si espandevano fino a rivestire una valenza esplicativa universale. Questi principi sembravano possedere una capacità critica che investiva la comprensione stessa dei processi storici e sociali. Si trattò di libri come Psicoanalisi delle nevrosi da guerra (1915-16), Al di là del principio del piacere (1920) e Complementi alla teoria del sogno. (12)
Nel 1921 Freud condusse a termine il saggio Psicologia delle masse e analisi dell'Io, con cui tentò di esporre alcune teorie psicoanalitiche complesse che spiegassero i processi psicologici che stavano alla base dei comportamenti delle grandi masse. L’Europa di quegli anni era un terreno di studio favorevole per chiunque volesse esercitarsi nello studio dei comportamenti umani nel contesto di fenomeni storici che vedevano la partecipazione di larghi strati delle popolazioni. A Oriente, l’Impero Russo non esisteva più. La nuova Russia bolscevica aveva segnato l’ingresso prepotente dell’utopia marxista sul terreno storico. In Occidente, le tensioni ed i conflitti sociali che si verificarono nelle nazioni in cui maggiori erano state le conseguenze belliche e le trasformazioni innescate dai nuovi confini degli stati nazionali, provocarono il desiderio di un mutamento verso un modello di vita e di sviluppo radicalmente avverso alle più grandi e consolidate Democrazie Europee, come la Francia e l’Inghilterra. La nascita del Fascismo in Italia, con la sua astuta utilizzazione dei meccanismi del consenso popolare in funzione sovvertitrice delle istituzioni, costituì l’esempio devastante che avrebbe aiutato e ispirato la presa del potere di un totalitarismo ben più spietato e determinato nell’affermare la sua volontà di potenza e di repressione della libertà individuale dell’uomo. L’Europa di quegli anni non si accorse subito del pericolo. La creazione nel 1919 della Società delle Nazioni, sotto l’egida e l’ispirazione del presidente americano, il democratico Thomas Woodrow Wilson (1856-1924), avrebbe dovuto costituire un baluardo e un ostacolo al ripetersi di guerre catastrofiche come era stato il conflitto appena terminato. Tuttavia la Società delle Nazioni non aveva alcun potere effettivo di opporsi a una deriva autoritaria e antidemocratica di chi avesse voluto intraprendere la strada verso un regime dittatoriale. Non aveva un esercito, né alcun potere economico effettivo da esercitare e in più era sotto la ferrea tutela della Francia e dell’Inghilterra, le due maggiori potenze vincitrici del Conflitto mondiale. Gli Stati Uniti, nonostante fossero stati determinanti per la sconfitta degli Imperi Centrali, si erano infatti defilati politicamente molto presto dalla Società delle Nazioni, che pure avevano contribuito a fondare. Gli anni successivi al 1918 furono difficili per le nazioni Europee. L’intero continente doveva adattarsi a nuove realtà geografiche ed economiche, mentre l’economia era stremata e da riconvertire dopo cinque anni di guerra. La prima nazione a venirne drammaticamente coinvolta fu l’Italia, che assistette impotente alla nascita del Fascismo.
Anche la riflessione di Freud sul significato più profondo della Teoria Psicoanalitica stava cambiando. Una nuova pulsione veniva ad assumere un ruolo importante nella sua visione dell’articolarsi della psiche umana. Si trattava della pulsione autodistruttiva o Pulsione di morte (Thanatos), che veniva a contrapporsi a quella di vita, o Pulsione erotica (Eros). Quest’ultima tendeva alla ricerca del piacere e attraverso esso alla continuazione della vita. (6, 12)
La contrapposizione tra Eros e Thanatos era presente in modo dialettico in ogni persona. Thanatos poteva provocare anche comportamenti autodistruttivi, legati a una autopunizione per l’impossibilità, cosciente o meno, di raggiungere un piacere gratificante. Oppure, cosa peggiore, l’istinto di morte poteva essere incanalato e deviato verso l’esterno dall’individuo, provocando comportamenti aggressivi e violenti verso chi venisse individuato come diverso e perciò nemico. Per una coincidenza storica singolare, ma non troppo, gli anni del dopoguerra videro emergere delle ideologie totalitarie che sembravano rivestire un ruolo di personificazione di istinti tragici e distruttivi. Eppure la parvenza democratica nelle fasi iniziali dell’ascesa di questi totalitarismi era stata salvaguardata. Mussolini ricevette un incarico ufficiale dal Re Vittorio Emanuele III a formare un governo sotto l’egida del Partito Fascista e Adolf Hitler andò al potere in seguito alla vittoria in regolari elezioni, che gli permisero di ottenere l’incarico di cancelliere dalle mani del vecchio feldmaresciallo e presidente del Reich Paul von Hindenburg. Poi, inesorabilmente, la macchina ideologica nazista iniziò a modificare rapidamente, con la forza e la brutalità, le regole democratiche e civili. Freud assistette con consapevole amarezza e distacco a questi eventi. Ne costituisce una prova eloquente il carteggio da lui intrapreso con Albert Einsten negli anni tra il 1932 ed il 1933, alla vigilia dunque dell’avvento del Nazionalsocialismo in Germania e dell’emanazione delle famigerate Leggi Razziali. (28)
I due uomini si conoscevano già da qualche anno. Nel 1926 Freud aveva incontrato personalmente Einstein a Berlino e aveva avuto con lui uno scambio di idee e un vivace confronto umano, anche se i rispettivi campi di indagine e di studio apparivano loro troppo lontani per poter essere influenzati reciprocamente. Qualche anno dopo, mentre le nuvole del totalitarismo si addensavano sui cieli d’Europa, la Società delle Nazioni chiese ad Einstein di poter pubblicare e diffondere uno scambio di opinioni sul problema della guerra che il fisico aveva avuto con il medico e psicoanalista austriaco. Ne nacque un piccolo carteggio, dal titolo di Perché la guerra, che venne stampato nel 1933.
Scrisse Einstein:
Gaputh (Potsdam), 30 luglio 1932
“Caro signor Freud,
la proposta, fattami dalla Società delle Nazioni e dal suo “Istituto internazionale di cooperazione intellettuale” di Parigi, di invitare una persona di mio gradimento a un franco scambio d’opinioni su un problema qualsiasi da me scelto, mi offre la gradita occasione di dialogare con Lei circa una domanda che appare, nella presente condizione del mondo, la più urgente fra tutte quelle che si pongono alla civiltà. La domanda è: c’è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra? E’ ormai risaputo che, col progredire della scienza moderna, rispondere a questa domanda è divenuta una questione di vita o di morte per la civiltà da noi conosciuta, eppure, nonostante tutta la buona volontà, nessun tentativo di soluzione è purtroppo approdato a qualcosa…”
da Sigmund Freud, Perché la guerra? (Carteggio con Einstein ed altri scritti),
Torino, 1975 (28)
Continuando nella sua argomentazione, Einstein poneva l’accento sulla necessità dell’istituzione di un organismo sovranazionale, cui i singoli stati demandassero una parte della loro sovranità e che fosse pertanto in grado, anche attraverso mezzi coercitivi, di assicurare la pace. Rendendosi conto dell’inutilità degli sforzi di riuscire ad ottenere la formazione di un’Autorità che costituisse un fattore di equilibrio riconosciuto come sovranazionale, Einstein si andava ponendo alcuni interrogativi sulla natura umana di cui chiedeva conto e spiegazione all’esperienza professionale di Freud:
“… L’insuccesso, nonostante tutto, dei tentativi intesi nell’ultimo decennio a realizzare questa meta, ci fa concludere senz’ombra di dubbio che qui operano forti fattori psicologici che paralizzano gli sforzi. Alcuni di questi fattori sono evidenti. La sete di potere della classe dominante è in ogni Stato contraria a qualsiasi limitazione della sovranità nazionale. Questo smodato desiderio di potere politico si accorda con le mire di chi cerca solo vantaggi mercenari, economici. Penso soprattutto al piccolo, ma deciso gruppo di coloro che, attivi in ogni Stato e incuranti di ogni considerazione e restrizione sociale, vedono nella guerra, cioè nella fabbricazione e vendita di armi, soltanto un occasione per promuovere i loro interessi personali e ampliare la loro personale autorità. […] Ci troviamo subito di fronte a un’altra domanda: come è possibile che la minoranza ora menzionata riesca ad asservire alle proprie cupidigie la massa del popolo, che da una guerra ha solo da soffrire e da perdere? (Parlando della maggioranza non escludo i soldati, di ogni grado, che hanno scelto la guerra come loro professione, convinti di giovare alla difesa dei più alti interessi della loro stirpe e che l’attacco sia spesso il miglior metodo di difesa). Una risposta ovvia a questa domanda sarebbe che la minoranza di quelli che di volta in volta sono al potere ha in mano prima di tutto la scuola e la stampa e per lo più anche le organizzazioni religiose. Ciò consente loro di organizzare e sviare i sentimenti delle masse, rendendoli strumenti della propria politica …”
da Sigmund Freud, Perché la guerra? (Carteggio con Einstein ed altri scritti), Torino, 1975 (28)
Infine, Einstein poneva a Freud un interrogativo cruciale, consistente nel fatto che fosse possibile in qualche modo controllare e indirizzare in modo positivo gli istinti più distruttivi presenti nell’animo umano:
“…Qui, forse, è il nocciolo del complesso di fattori che cerchiamo di districare, un enigma che può essere risolto solo da chi è esperto nella conoscenza degli istinti umani. Arriviamo così all’ultima domanda. Vi è una possibilità di dirigere l’evoluzione psichica degli uomini in modo che diventino capaci di resistere alle psicosi dell’odio e della distruzione? Non penso qui affatto solo alle cosiddette masse incolte. L’esperienza prova che piuttosto la cosiddetta “intellighenzia” cede per prima a queste rovinose suggestioni collettive, poiché l’intellettuale non ha contatto diretto con la rozza realtà, ma la vive attraverso la sua forma riassuntiva più facile, quella della pagina stampata. Concludendo: ho parlato sinora soltanto di guerre tra Stati, ossia di conflitti internazionali. Ma sono perfettamente consapevole del fatto che l’istinto aggressivo opera anche in altre forme e in altre circostanze (penso alle guerre civili, per esempio, dovute un tempo al fanatismo religioso, oggi a fattori sociali; o, ancora, alla persecuzione di minoranze razziali). Ma la mia insistenza sulla forma più tipica, crudele e pazza, di conflitto tra uomo e uomo era voluta, perché abbiamo qui l’occasione migliore per scoprire i mezzi e le maniere mediante i quali rendere impossibili tutti i conflitti armati. So che nei Suoi scritti possiamo trovare risposte esplicite o implicite a tutti gli interrogativi posti da questo problema, che è insieme urgente e imprescindibile. Sarebbe tuttavia della massima utilità a noi tutti se Lei esponesse il problema della pace mondiale alla luce delle Sue recenti scoperte, perché tale esposizione potrebbe indicare la strada a nuovi e validissimi modi d’azione…”
Molto cordialmente, Suo Albert Einstein
da Sigmund Freud, Perché la guerra? (Carteggio con Einstein ed altri scritti), Torino, 1975 (28)
La risposta di Freud fu alquanto pessimistica e molto circostanziata, semplice nelle argomentazioni e insieme meditata, come era consuetudine del personaggio. Fin dall’inizio, richiamandosi all’equilibrio nelle società umane tra il diritto dei molti e la violenza del singolo o di pochi, Freud ribadì quella che era la sua convinzione ormai radicata sulle pulsioni primarie dell’uomo:
“…Noi presumiamo che le pulsioni dell’uomo siano soltanto di due specie, quelle che tendono a conservare e a unire - da noi chiamate sia erotiche (esattamente nel senso di Eros nel Convivio di Platone), sia sessuali, estendendo intenzionalmente il concetto popolare di sessualità - e quelle che tendono a distruggere e a uccidere; queste ultime le comprendiamo tutte nella denominazione di pulsione aggressiva o distruttiva […] Lei vede che propriamente si tratta soltanto della delucidazione teorica della contrapposizione tra amore e odio, universalmente nota e che forse è originariamente connessa con la polarità di attrazione e repulsione che interviene anche nel Suo campo di studi. Non ci chieda ora di passare troppo rapidamente ai valori di bene e di male. Tutte e due le pulsioni sono parimenti indispensabili, perché i fenomeni della vita dipendono dal loro concorso e dal loro contrasto. Ora, sembra che quasi mai una pulsione di un tipo possa agire isolatamente, essa è sempre legata - vincolata, come noi diciamo - con un certo ammontare della controparte, che ne modifica la meta o, talvolta, solo così ne permette il raggiungimento. Per esempio, la pulsione di autoconservazione è certamente erotica, ma ciò non toglie che debba ricorrere all’aggressività per compiere quanto si ripromette. Allo stesso modo la pulsione amorosa, rivolta a oggetti, necessita di un quid della pulsione di appropriazione, se veramente vuole impadronirsi del suo oggetto. La difficoltà di isolare le due specie di pulsioni, nelle loro manifestazioni, ci ha impedito per tanto tempo di riconoscerle…”
da Sigmund Freud, Perché la guerra? (Carteggio con Einstein ed altri scritti), Torino, 1975 (28)
In questo modo Freud poneva come obiettivo della sua argomentazione l’impossibilità di poter eliminare l’istinto di aggressività dalla specie umana. In più, ad inquinare il quadro, Freud evidenziava come l’aggressività fosse stata spesso diretta dal potere religioso o politico in malafede, utilizzando la giustificazione dei nobili ideali da cui doveva venire mossa:
“…Pertanto, quando gli uomini vengono incitati alla guerra, è possibile che si destino in loro un’intera serie di motivi consenzienti, nobili e volgari, quelli di cui si parla apertamente e altri che vengono taciuti. Non è il caso di enumerarli tutti. Il piacere di aggredire e distruggere ne fa certamente parte; innumerevoli crudeltà della storia e della vita quotidiana confermano la loro esistenza e la loro forza. Il fatto che questi impulsi distruttivi siano mescolati con altri impulsi, erotici e ideali, facilita naturalmente il loro soddisfacimento. Talvolta, quando sentiamo parlare delle atrocità della storia, abbiamo l’impressione che i motivi ideali siano serviti da paravento alle brame di distruzione; altre volte, trattandosi per esempio di crudeltà della Santa Inquisizione, che i motivi ideali fossero preminenti nella coscienza, mentre i motivi distruttivi recassero loro un rafforzamento inconscio. Entrambi i casi sono possibili…”
da Sigmund Freud, Perché la guerra? (Carteggio con Einstein ed altri scritti), Torino, 1975 (28)
Dove però la lettura di Freud del fenomeno bellico appare particolarmente innovativa è nel suo tentativo di comprenderlo da un punto di vista sociale. La civiltà moderna secondo lui ha deviato le pulsioni degli uomini civilizzati dal manifestare in modo chiaro la loro aggressività. Questa è stata interiorizzata, dando luogo a complessi e sensi di colpa. Inoltre la riduzione dell’aggressività verso i propri simili recava con sé anche una riduzione della pulsione sessuale e la deviazione verso altri oggetti di desiderio. Ne sarebbe conseguita per prima cosa un calo della natalità nel Mondo Occidentale, al contrario di quanto avveniva nelle popolazioni più primitive:
“…Orbene, poiché la guerra contraddice nel modo più stridente a tutto l’atteggiamento psichico che ci è imposto dal processo civile, dobbiamo necessariamente ribellarci contro di essa: semplicemente non la sopportiamo più; non si tratta soltanto di un rifiuto intellettuale e affettivo, per noi pacifisti si tratta di un’intolleranza costituzionale, per così dire della massima idiosincrasia. E mi sembra che le degradazioni estetiche della guerra non abbiano nel nostro rifiuto una parte molto minore delle sue crudeltà. Quanto dovremo aspettare perché anche gli altri diventino pacifisti? Non si può dirlo, ma forse non è una speranza utopistica che l’influsso di due fattori - un atteggiamento più civile e il giustificato timore degli effetti di una guerra futura - ponga fine alle guerre in un prossimo avvenire. Per quali vie dirette o traverse non possiamo indovinarlo. Nel frattempo possiamo dirci: tutto ciò che promuove l’evoluzione civile lavora anche contro la guerra. La saluto cordialmente e Le chiedo scusa se le mie osservazioni L’hanno delusa…”
Suo Sigm. Freud
da Sigmund Freud, Perché la guerra? (Carteggio con Einstein ed altri scritti), Torino, 1975 (28)
Come si vede, si trattò di una conclusione alquanto utopistica e rassicurante, anche se era partita da considerazioni lucide e pessimistiche. Siamo ormai nel 1932. Ancora pochi mesi e nel gennaio del 1933 Adolf Hitler sarà nominato cancelliere dal vecchio Hinderburg, ultimo presidente della Repubblica Democratica di Weimar. Il Nazismo prendeva così il potere e con esso diveniva ufficiale e praticata senza ostacoli la sua ideologia aberrante di sopraffazione violenta del più forte sul più debole. Rimane incredibile constatare come Freud sembri non accorgersi di questo pericolo che era ormai alle porte. Forse il suo ruolo di intellettuale stimato e celebre in patria e all’estero poteva avergli conferito un’aspettativa di inviolabilità. Si spiega così il suo voler restare a Vienna fino all’ultimo, anche dopo l’annessione dell’Austria al Terzo Reich, avvenuta nel marzo del 1938. Solo allora, preoccupato per un fermo operato dalla Gestapo nei confronti dell’amata figlia Anna, accettò di lasciare Vienna. La casa dove Freud visse il suo ultimo anno di vita si trova a Londra, al numero 20 di Maresfield Gardens. E’ una bella casa con giardino, oggi sede del Freud Museum. Freud vi si trasferì con la moglie, la cognata, la figlia Anna e la domestica Paula Fichtl dopo un domicilio provvisorio in un’altra casa. Vi giunse il 27 settembre del 1938 e vi sistemò tutti gli arredi e le suppellettili della casa di Vienna, in Bergasse 19, dove era vissuto per così tanto tempo. Il tumore al palato di cui soffriva e che era stato operato e sottoposto a radioterapia qualche anno prima gli dava terribili dolori, cui sopperiva con l’utilizzo della morfina, continuando imperterrito a fumare gli amati sigari. La casa di Londra divenne meta delle visite di studiosi e personalità dell’arte e della cultura. Di queste occasioni di incontro ci restano alcuni filmati amatoriali, in cui Freud appare spesso seduto in giardino su di una sdraio, con una coperta sulle ginocchia e l’immancabile sigaro in mano, mentre osserva distaccato, ma con sguardo attento, quello che gli succede intorno. Il Professore si spense lentamente, in un’atmosfera ovattata dalla morfina, che lo teneva lontano dai dolori neoplastici e dalla rinnovata follia degli uomini. Il primo settembre del 1939 la Germania nazista invase la Polonia, dando inizio alla Seconda Guerra Mondiale.
Pochi giorni dopo, confortato dai suoi cari e dalla vicinanza della figlia Anna, Freud accettò una somministrazione di morfina a un dosaggio più elevato dei precedenti. Sarà l’ultima. Morirà serenamente nel sonno, alle tre di notte del 23 settembre 1939.
Pochi mesi prima, nel novembre del 1938, ormai trasferitosi nella sua ultima e definitiva abitazione di Maresfield Gardens, Freud aveva scritto queste parole al direttore del giornale Time and Tide:
"... dopo anni di duro lavoro ho dovuto lasciare la mia patria, ho visto dissolvere la società scientifica da me fondata, distrutti i nostri istituti, confiscata la casa editrice dagli invasori, sequestrati o mandati al macero i libri da me pubblicati, i miei figli esclusi dalle loro professioni... mi viene in mente un vecchio proverbio francese: il rumore è per il fatuo, la pena è per lo sciocco: l'uomo onesto e tradito se ne va senza pronunciare parola…"
da Sigmund Freud, Opere, 12 voll, Torino, 1976-1980 (11)
La vicenda umana di Sigmund Freud era veramente finita, ma non quella derivata dai suoi insegnamenti e dalle sue riflessioni. I pensieri del padre della Psicoanalisi sarebbero sopravvissuti agli anni di barbarie e distruzioni che si stavano preparando, come l’arrivo di nuvole nere in un cielo già tempestoso. Il tempo avrebbe infine restituito quello che ora sembrava perduto senza speranza all’umanità e alla ragione.
4. Un’ultima e importante questione:
la Psicoanalisi è una Scienza?
In alcuni passi presenti dei capitolo conclusivo del suo romanzo, La Coscienza di Zeno, Italo Svevo ci racconta alcune conclusioni assai inquietanti sull’esistenza cui è giunto il personaggio principale del libro, Zeno Cosini:
“…Il dottore presta fede troppo grande a quelle mie benedette confessioni che non vuole restituirmi perché le riveda. Dio mio! Egli non studiò che la medicina e perciò ignora che cosa significhi scrivere in italiano per noi che parliamo e non sappiamo scrivere il dialetto. Una confessione in iscritto è sempre menzognera. Con ogni nostra parola toscana noi mentiamo! Se egli sapesse come raccontiamo con predilezione tutte le cose per le quali abbiamo pronta la frase e come evitiamo quelle che ci obbligherebbero di ricorrere al vocabolario! E' proprio così che scegliamo dalla nostra vita gli episodi da notarsi. Si capisce come la nostra vita avrebbe tutt'altro aspetto se fosse detta nel nostro dialetto…"
da I. Svevo, La Coscienza di Zeno, 1923 (29)
Svevo affermava in questo modo che era il linguaggio a dirigere il pensiero e che era solo in base alle capacità tecniche di espressione possedute da ogni individuo che si poteva comunicare tra esseri umani. Ci si trasmetteva solo ciò che si era in grado di comunicare al meglio e con efficacia, non naturalmente ogni cosa o idea possibile. Solo quello di cui potevamo fare una cernita, una scelta significativa tra i molti contenuti del pensiero era illustrato al medico che ci interrogava e che ci avrebbe ascoltato. Come se non bastasse, Zeno (cioè Svevo) aggiungeva:
“…E' così che a forza di correre dietro a quelle immagini, io le raggiunsi. Ora so di averle inventate. Ma inventare è una creazione, non già una menzogna. Le mie erano delle invenzioni come quelle della febbre, che camminano per la stanza perché le vediate da tutti i lati e che poi anche vi toccano. Avevano la solidità, il colore, la petulanza delle cose vive. A forza di desiderio, io proiettai le immagini, che non c'erano che nel mio cervello, nello spazio in cui guardavo, uno spazio di cui sentivo l'aria, la luce ed anche gli angoli contundenti che non mancarono in alcuno spazio per cui io sia passato…"
da I. Svevo, La Coscienza di Zeno, 1923 (29)
Alla luce di queste affermazioni, possiamo sostenere come il nevrotico non racconti compiutamente sé stesso all’analista. Egli si limita a raccogliere le indicazioni che il linguaggio e il suo modo di interpretare la realtà gli suggeriscono. Infine, da paziente, “inventa” una parte delle cose che racconta al suo medico, non perché pensi di mentire così facendo, ma perché non può fare altro. Crea una parte di ciò che racconta in base alla padronanza e al tipo di linguaggio che possiede e si attende di essere esaminato secondo lo stesso metro, secondo una modalità che ha inconsapevolmente o meno suggerito al suo terapeuta. Abbiamo utilizzato questi passi della Coscienza di Zeno per introdurre un po’ provocatoriamente il ragionamento sulla validità scientifica della Psicoanalisi. Una prima critica alla sua attendibilità scientifica fu quella avanzata dai neopositivisti del Circolo di Vienna. Secondo le idee di alcuni di questi filosofi, come Rudolf Carnap e Moritz Schlick, potevano essere definite scientifiche solo quelle affermazioni basate su di una verifica sperimentale empirica. Nel caso della Psicoanalisi questa difficoltà era particolarmente evidente. Le teorie psicoanalitiche erano sviluppate in un modo tale da non permettere sempre di correlare dei concetti teorici a quanto veniva materialmente osservato nella pratica clinica. Sui singoli casi clinici mancava inoltre una condotta di interpretazione univoca, che seguisse una metodica psicoanalitica rigorosa, perché era possibile fornire delle spiegazioni differenti a riguardo dei sintomi e della patologia psichica presentata dal paziente che si era preso in esame. (30, 31)
Anche nel pensiero di Karl Popper (1902-1994) vennero manifestate delle forti critiche alla scientificità della Psicoanalisi. Secondo Popper una teoria scientifica doveva poter essere falsificabile per essere considerata come tale. Nel pensiero di Popper il termine “falsificazione” indicava che gli enunciati di ogni teoria scientifica dovevano possedere la proprietà di essere in un futuro più o meno lontano dimostrati non esatti da parte di un teoria elaborata in un tempo successivo, la quale si sarebbe dimostrata più veritiera nello spiegare lo stesso concetto scientifico. (32)
Paradossalmente, la qualità che un enunciato scientifico avrebbe dovuto possedere per essere considerato più facilmente falsificabile era costituita da una caratteristica di precisione. Quanto più un enunciato era preciso, tanto più esso si sarebbe prestato ad essere superato da una diversa teoria scientifica, che avrebbe scoperto delle crepe nella sua architettura razionale e dimostrativa. Se invece venivano enunciate delle teorie con un alto tasso di indeterminatezza e suscettibili di un’interpretazione soggettiva, come avveniva appunto per la Psicoanalisi, sarebbe stato più difficile falsificarle. (32, 33)
Le conclusioni di Popper sulla scientificità della Psicoanalisi furono molto critiche. Secondo il filosofo austriaco la Psicoanalisi non poteva essere ritenuta una scienza, perché le conclusioni a cui essa giungeva attraverso i suoi enunciati rivestivano un carattere di eccessiva genericità. Si trattava di affermazioni che non potevano essere falsificate, perché erano in grado di affermare una cosa e il suo esatto contrario partendo da un terreno psichico individuale non verificabile in modo certo attraverso l’esperienza. Scrisse Popper in proposito:
“…quanto all'epica freudiana dell'Io, del Super-io e dell'Es, non si può avanzare nessuna pretesa ad uno stato scientifico, più fondatamente di quanto lo si possa fare per l'insieme delle favole omeriche dell'Olimpo. Queste teorie descrivono alcuni fatti, ma alla maniera dei miti. Esse contengono delle suggestioni psicologiche assai interessanti, ma in forma non suscettibile di controllo. Ciò è in contrasto con la maggior parte delle teorie fisiche le quali sono del tutto e altamente falsificabili sin dall'inizio…”
da K. Popper, Congetture e Confutazioni, Lo sviluppo della concezione scientifica,
Bologna, 1972 (32)
Un’altra fonte di critica alle teorie psicanalitiche fu costituita dall’Ermeneutica. Questa è una parte della filosofia che si interessa delle regole interpretative dei testi e delle idee che li hanno generati. Un esponente importante di questa corrente filosofica fu Wilhelm Dilthey (1833-1911), che dobbiamo citare per la sua rilevanza nell’ambito dell’interpretazione filosofica della Psicoanalisi. (34) Originale fu la distinzione operata da Dilthey tra lo spiegare e il comprendere. Lo spiegare costituiva una modalità di investigazione del reale che trovava il suo riferimento nelle Scienze naturali e nella loro modalità conoscitiva di tipo empirico. Il comprendere si basava invece su di un impegno conoscitivo diverso, in cui l’individuo impiegava e integrava tra di loro tutte le sue facoltà umane, come l’intelletto, il sentimento e la capacità di percepire la verità. Il comprendere risultava così più efficace per quanto riguardava lo studio delle Scienze storiche e sociali. Questa distinzione che abbiamo appena descritto, operata da Dilthey tra Scienze naturali e Scienze dello spirito o Scienze umane, è stata utilizzata da alcuni studiosi, come Jürgen Habermas (1929) e Paul Ricoeur (1913-2005) per collocare la Psicoanalisi all’interno delle Scienze umane e sociali, invece che nel novero delle Scienze naturali. (33, 34)
Secondo questi due filosofi, si sarebbe verificato una specie di fraintendimento scientifico, che avrebbe inserito la Psicoanalisi nel novero delle Scienze naturali, le quali utilizzano la verifica empirica dei loro enunciati, invece che nell’ambito delle Scienze storico-sociali, le così dette Scienze Umane. Questa diversa prospettiva conoscitiva dei risultati psicoanalitici avrebbe svincolato le ipotesi freudiane dalle angustie metodologiche create dal dover ottemperare a passaggi sperimentali obbligati. Scomodi, verrebbe da aggiungere, come quelli forniti dalla prova scientifica, dalla ripetibilità dei risultati ottenuti, dal sottostare al criterio di possibile falsificazione e via dicendo.
La Psicoanalisi quindi, secondo un’interpretazione ermeneutica, non dovrebbe preoccuparsi di spiegare le cause dei fenomeni da essa indagati, ma focalizzerebbe la sua attenzione sul significato stesso dell’oggetto del suo studio, indipendentemente da una coerenza o meno con dei dati rigidamente sperimentali. Lo stesso rapporto tra lo psicoanalista e il suo paziente andrebbe visto come la costruzione di una storia coerente della vicenda clinica del soggetto, che permetterebbe di spiegare in modo utile i significati, cioè le ragioni che sono state alla base del suo agire. Questa nuova libertà interpretativa conferita dall’Ermeneutica alla Psicoanalisi era però più una fuga dal ruolo di possibile disciplina scientifica che una rivendicazione orgogliosa di un’autorevolezza conoscitiva e di una diversa affidabilità metodologica. (35, 36)
Su queste premesse, si è venuta a confrontarsi la critica alla scientificità della Psicoanalisi formulata dal filosofo della scienza tedesco Adolf Grünbaum in un suo studio del 1984, tradotto in Italiano con il titolo di I fondamenti della Psicoanalisi. (37)
Secondo Grünbaum, l’inserimento effettuato dagli ermeneuti come Habermas della Psicoanalisi nel contesto delle Scienze sociali non era esatto. Lo stesso Freud aveva sostenuto che meccanismi come quello della rimozione nella genesi delle nevrosi dovevano essere intesi come un effetto causale vero e proprio, nel senso naturale del termine. La stessa contrapposizione tra Scienze naturali o astoriche e Scienze umane o storiche appariva per lui poco significativa. Le teorie scientifiche sembravano essere molto più dipendenti dal contesto storico in cui venivano elaborate rispetto a una loro presunta neutralità. L’Elettromagnetismo e la Termodinamica ne costituivano un esempio eloquente, come pure lo scetticismo con cui le teorie sulla Termodinamica di Ludwig Boltzmann vennero inizialmente accolte stavano a dimostrare. (36, 37)
Un’ulteriore obiezione all’interpretazione ermeneutica della Psicoanalisi poteva essere posta dalla possibilità di effettuare delle verifiche epidemiologiche a posteriori sulla validità delle conclusioni cui era giunto lo psicoanalista nella sua interazione con il soggetto esaminato. In questo modo veniva a cadere l’ipotesi di una completa autoreferenzialità di quanto narrato dal paziente nei suoi colloqui. Le conclusioni a cui si era pervenuti attraverso l’interazione tra psicoanalista e paziente potevano e dovevano, secondo Grünbaum, essere verificate in modo statistico-epidemiologico, come qualsiasi altra malattia. (37, 38)
Un altro aspetto delle argomentazioni di Grünbaum riguardava gli scritti di Karl Popper sulla mancanza di falsificabilità delle conclusioni psicoanalitiche. Per Grünbaum, le argomentazioni di Popper non erano basate su elementi assoluti. In alcuni passi delle opere di Freud si trovavano ripensamenti e correzioni fondati sull’esame di singoli casi clinici, che facevano ipotizzare un possibile controllo basato sulla falsificabilità dei risultati psicoanalitici. Quello su cui la Psicoanalisi avrebbe dovuto con forza puntare, secondo Grünbaum, era invece una verifica a posteriori e obiettiva degli esiti clinici raggiunti. Si sarebbe trattato in questo caso di una modalità d’azione strettamente scientifica, che implicava l’utilizzo di un gruppo omogeneo di controllo, il quale avrebbe permesso di paragonare i risultati ottenuti in una coorte di pazienti trattati con il metodo psicanalitico rispetto a soggetti portatori della stessa patologia che avevano invece ricevuto un’altra modalità d’intervento. Ne conseguiva la necessità per la Psicoanalisi di migliorare e perfezionare i propri strumenti di misurazione dei risultati. Si trattava di una sfida che gli Psicoanalisti dovevano raccogliere e portare avanti, se non volevano essere relegati in una condizione di autoreferenzialità scientifica. Anche Freud, in alcuni passi delle sue opere, si era accorto della necessità di un ulteriore lavoro teorico ed epistemologico per conferire una maggiore dignità scientifica alla Psicoanalisi. Attraverso l’Argomento della concordanza tra quanto raccontato dal paziente e quanto osservato dallo psicoanalista, già nel 1917 Freud riteneva che non si potessero accogliere interpretazioni non corrispondenti al vero rispetto a quanto supposto dall’analista nelle sue conclusioni. (37, 38)
Vorrei concludere con un riferimento al pensiero di David Hume. Se rielaboriamo le idee del filosofo scozzese appare impossibile riuscire a dare una risposta sicura agli interrogativi che sono stati prima discussi. Scriveva Hume, nelle prime pagine del suo Trattato sulla natura umana (1748), che tutte le Scienze non potevano che definirsi umane perché esse erano state formulate unicamente dall’uomo con i suoi mezzi intellettivi e la sua ragione. (39)
Per questo motivo, anche le Scienze che ci sembravano le più distaccate da un’interpretazione soggettiva della realtà, come la matematica, la fisica, la chimica, risentivano invece della modalità di formulazione dello scienziato che le aveva teorizzate e aveva partecipato a modificarle nel tempo, intervenendo sulle loro conclusioni e affermazioni. Con il consueto e pragmatico sentimento di apparente disinganno così aggiungeva al riguardo il filosofo in pieno Secolo dei Lumi:
“…È comune agli autori che pretendono di avere scoperto fatti nuovi nel campo della filosofia e delle scienze vantare i propri sistemi screditando l’opera di quanti li hanno preceduti. Se essi si contentassero di lamentare l’ignoranza in cui ancora ci troviamo sui problemi più importanti che si presentano all’esame della ragione umana, pochi tra i cultori delle scienze potrebbero dare loro torto. Chi possiede senno e sapere s’avvede infatti facilmente come siano deboli le basi dei sistemi più accreditati, anche di quelli che accampano maggiori pretese al rigore e alla profondità del ragionamento. Principi accertati ciecamente e conseguenze mal dedotte, mancanza di coerenza nelle parti e di evidenza nell’insieme: ecco quel che s’incontra dovunque nei sistemi dei più eminenti filosofi […] Non occorrono cognizioni molto profonde per convincersi dello stato di imperfezione delle scienze attuali. Anche chi se ne sta fuori della porta può giudicare, dal rumore e dalle grida, che le cose non vanno troppo bene all’interno. Non c’è niente, infatti, che non venga messo in discussione e su cui i dotti non abbiano opinioni contrarie. Le questioni più frivole non sfuggono alla controversia e intanto non sappiamo risolvere quelle più importanti. Le dispute si moltiplicano come se tutto fosse incerto e tuttavia sono condotte con tanto accanimento come se tutto fosse certo. Non è la ragione che porta il premio in tale trambusto, ma l’eloquenza; basta che ognuno sappia presentarla con arte e può guadagnare proseliti all’ipotesi più stravagante. La vittoria non è degli uomini che maneggiano la picca e la spada, ma dei trombettieri, tamburini e musicanti dell’esercito…”
da David Hume, Trattato sulla natura umana, 1748, (39)
Come sarà dunque possibile per l’uomo analizzare sé stesso utilizzando gli stessi strumenti razionali con cui esamina il mondo esterno? Si cadrà magari e inevitabilmente nel consueto tranello tautologico, come nell’argomento delle Isole felici. Il luogo di fantasia di cui non possiamo possedere prova certa dell’esistenza solo per il fatto che affermiamo con forza la sua realtà costitutiva. Questo argomento, che fu utilizzato dal monaco Gaunilone di Marmoutier nella sua disputa con Anselmo d’Aosta, riappare ogni volta che si tenta di affermare in assoluto una funzione di verità con gli strumenti della conoscenza umana. (40)
A mio parere la Psicoanalisi deve essere vista come un tentativo geniale di trovare una chiave interpretativa coerente del modo con cui si forma la personalità dell’individuo e di spiegare come questi riesca a governare, o almeno provi a farlo, le sue pulsioni, desideri e passioni. I limiti della visione freudiana della mente umana sono davanti agli occhi e alla ragione di tutti, eppure il fascino esercitato da un sistema di conoscenza coerente e a suo modo funzionante, come quello ideato da Sigmund Freud, continua a rivendicare un suo ruolo e una sua legittimità. Una volta chiariti gli aspetti metodologici più dubbi e preservato il ruolo di critica al Sistema psicoanalitico, non si vede perché a questa esperienza non debba essere riconosciuta una sua autorevolezza e utilità. Rifuggendo dallo sciagurato tentativo di tener conto solo di ipotesi apparentemente più scientifiche e forse per questo motivo più o meno legittimate solo da una loro transitoria e inevitabilmente fugace importanza.
Bibliografia
- Schnitzler A., Il ritorno di Casanova, Milano, 1984.
- Crankshaw E., Il tramonto di un impero. La fine degli Asburgo. Milano, 1992.
- May A. A., La monarchia asburgica, Bologna, 1973.
- Vegetti Finzi S., Storia della Psicoanalisi: autori, opere, teorie 1895-1985, Milano, 1987.
- Zanuso B., La nascita della psicoanalisi. Freud nella cultura della Vienna di fine secolo, Milano, 1982.
- Jones E., Vita ed opere di Freud, 3 voll., Milano, 1962.
- Freud S., Lettere 1873-1939, Torino, 1960.
- Landman P., Freud, Milano, 2000.
- Ellenberger H.F., La scoperta dell'inconscio, Torino, 1970.
- Sulloway F. J., Freud, biologo della psiche: al di là della leggenda psicoanalitica, Milano, 1982.
- Laplanche J.-Pontalis J. B., Enciclopedia della Psicoanalisi, Roma-Bari, 1981.
- Freud S., Opere, 12 voll, Torino, 1976-1980.
- Musatti C., Trattato di Psicoanalisi, Torino, 1949.
- Brenner C., Breve corso di psicoanalisi, Firenze, 1967.
- Farese G., Schnitzler: «Fuga nelle tenebre». Letteratura e malattia, in L’arco di Giano, Rivista di Medical Humanities, n. 18 (1998), pp. 229-237.
- Schnitzler A., Doppio Sogno, Milano, 1984.
- Schnitzler A., Fuga nelle tenebre, Milano, 1984.
- Crescini A., a cura di, Freud-Adler-Jung, Psicoanalisi e filosofia, Brescia, 1983.
- Fromm E., Marx e Freud, Milano, 1968.
- Fromm E., Avere o Essere, Milano, 1977.
- Ellenberger H.F., Introduzione a Jung, Torino, 2006.
- Carotenuto A., Diario di una segreta simmetria, Roma, 1980.
- Lettere tra Freud e Jung, Torino, 1974.
- Carotenuto A., Jung e la cultura del 20° secolo, Milano, 2000.
- Jung. C. G., Introduzione alla psicologia analitica, Torino, 2000.
- Jung. C. G., L’uomo e i suoi simboli, Milano, 2007.
- Lettere tra Freud e Lou Andreas Salomè 1912-1936, Torino, 1978.
- Freud S., Perché la guerra? (Carteggio con Einstein ed altri scritti), Torino, 1975.
- Svevo I., La coscienza di Zeno, 1923.
- Longhin L., La fondazione epistemologica del sapere psicoanalitico, Boll.Soc. Fil. it., n. 137, 47-63, 1989a.
- Longhin L., Alle origini del pensiero psicoanalitico, Roma, 1992.
- Popper K. R., Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della concezione Scientifica, Bologna 1972.
- Agazzi E., Criteri epistemologici fondamentali delle discipline psicoanalitiche, in Siri G., (a cura di) Problemi epistemologici della psicologia, Milano, 1976.
- Bianco F., Introduzionea Dilthey, Roma-Bari, 1985.
- Blight J.G., Must psychoanalysis retreat to hermeneutics? Psychoanalythic theory in the light of Popper’s evolutionary epistemology, Psychoanalysis and Contemporary Thought, 4: 147-206, 1981.
- Mattana G., Condizioni di possibilità della psicoanalisi come scienza: una discussione delle tesi di Popper e di Grünbaum, in Temi e problemi, Torino, 1998.
- Grünbaum A., I fondamenti della psicoanalisi, Milano, 1988.
- Migone P., La psicoanalisi è una scienza? Panorama storico del problema e dibattito attuale sollevato da Grünbaum, Il Ruolo Terapeutico, 50: 69-75, 1989.
- Hume D., Trattato sulla natura umana, Milano, 2009.
- Gaunilone, La difesa dello stolto, in Anselmo di Aosta, Proslogion, a cura di A. Caretta e L. Samarati, Novara 1994.